![]()
Scipio Slataper
il suo tempo, la sua città
miscellanea di studi
a cura di Fulvio Senardi
pubblicato in dicembre del 2013

|
|
PUBBLICAZIONI
SAGGISTICA
Scipio Slataper a cura di Fulvio Senardi |
|
 |
![]() ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
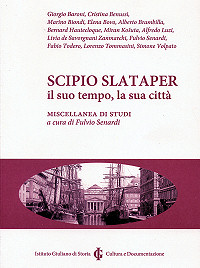 È con soddisfazione, credo, del tutto motivata che, tanto a nome mio personale quanto come portavoce dell'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione e del Gruppo 85 Skupina, licenzio questa miscellanea, derivata da una serie di iniziative svoltesi nel 2012, centenario della pubblicazione del Mio Carso. Evento che in prima battuta si è svolto, com'è ovvio, a Trieste, dove il 3 maggio, in una giornata di studio promossa dalle associazioni citate, si è ricordato Scipio Slataper, uomo e scrittore; l'unico momento di riflessione pubblica, aggiungo, tenutosi in città per onorare chi le ha eretto uno dei suoi più celebri monumenti letterari. Poi, qualche mese dopo, in un ottobre insieme mite e piovoso, a Besançon, presso la cui Università la professoressa Elena Bovo, riallacciandosi all'incontro triestino, ha voluto offrire ai suoi studenti la possibilità di entrare in contatto, nel corso di un incontro seminariale, con un autore ancora in gran parte sconosciuto in Francia. Da tali sinergie nasce il volume che queste pagine introducono: nel breve antefatto che lo ha preparato, la scelta e la raccolta dei materiali saggistici, alcuni relatori hanno gettato la spugna, nuovi studiosi si sono aggiunti in un rimescolamento di carte che non manca mai quando si coltivano programmi ambiziosi. Rimane il fatto che al libro che registra tanti convergenti sforzi ermeneutici spetta un significato particolare: una verifica dello stato dell'arte, relativamente alla critica slataperiana, che mette perfettamente in rilievo tanto le luci e le ombre di una fortuna, quanto le diverse velocità con cui la critica ha affrontato l'approfondimento dei diversi settori dell'operosità dello scrittore triestino. Riflessione collettiva di particolare interesse anche per l'eterogeneità delle forze coinvolte; e non parlo delle differenti prospettive critiche che hanno visto messi alla prova, nei due incontri di Trieste e di Besançon, i propri strumenti interpretativi. Fatti saggi (o disincantati) dalla crisi delle ideologie sappiamo ormai bene quanto poco senso abbia, in campo letterario, difendere il dogma di una verità come se da essa possa scaturire la parola unica e definitiva su un'esperienza di vita e di scrittura. Mentre è invece la collaborazione di metodologie e il calibrato eclettismo degli approcci che ne può dare il tutto tondo. Ciò cui intendevo alludere era invece la provenienza eterogenea - e in quanto tale, nella dialettica di voci, feconda di risultati - di coloro che hanno partecipato a questi incontri. Studiosi di vecchia generazione si sono incontrati con ricercatori più giovani, critici incardinati nell'Accademia hanno dialogato con intellettuali provenienti dai ranghi dell'associazionismo culturale, Maestri riconosciuti nel campo degli studi slataperiani e della letteratura triestina (Giorgio Baroni, Cristina Benussi, Alfredo Luzi) si sono fatti guida del percorso di neofiti, che da parte loro travasavano nel discorso comune il portato di diverse e non meno interessanti esperienze di ricerca. Per tacere poi delle utili occasioni di confronto tra "scuola" critica francese e italiana, nei limiti in cui di tali si può ancora parlare in epoca di globalizzazione omologante. Del resto è così che la cultura guadagna un effettivo valore sociale, allargandosi oltre gli ambienti più specialistici: si diffonde, forma humus, favorisce inaspettate germinazioni perfino tra i più giovani. Se poi la scuola aiutasse, liberata dalla morsa di penuria dove la costringe l'eterna "emergenza" italiana (per non dire del totale disinteresse a suo riguardo da parte di ceti dirigenti, protagonisti dell'«implacabile percorso di distruzione della scuola» - M. Boscaino), se poi i Media volessero tener dietro cessando di piegarsi alla «drogata e manipolata rapidità in cui tutto si trasforma in spettacolo» (Zanzotto, 1996) ecco che la Letteratura (e non si intendono i troppi Dan Brown della subcultura consumistica) potrebbe risultare veramente spendibile a favore dell'Italia civile (o meglio, da incivilire).
È con soddisfazione, credo, del tutto motivata che, tanto a nome mio personale quanto come portavoce dell'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione e del Gruppo 85 Skupina, licenzio questa miscellanea, derivata da una serie di iniziative svoltesi nel 2012, centenario della pubblicazione del Mio Carso. Evento che in prima battuta si è svolto, com'è ovvio, a Trieste, dove il 3 maggio, in una giornata di studio promossa dalle associazioni citate, si è ricordato Scipio Slataper, uomo e scrittore; l'unico momento di riflessione pubblica, aggiungo, tenutosi in città per onorare chi le ha eretto uno dei suoi più celebri monumenti letterari. Poi, qualche mese dopo, in un ottobre insieme mite e piovoso, a Besançon, presso la cui Università la professoressa Elena Bovo, riallacciandosi all'incontro triestino, ha voluto offrire ai suoi studenti la possibilità di entrare in contatto, nel corso di un incontro seminariale, con un autore ancora in gran parte sconosciuto in Francia. Da tali sinergie nasce il volume che queste pagine introducono: nel breve antefatto che lo ha preparato, la scelta e la raccolta dei materiali saggistici, alcuni relatori hanno gettato la spugna, nuovi studiosi si sono aggiunti in un rimescolamento di carte che non manca mai quando si coltivano programmi ambiziosi. Rimane il fatto che al libro che registra tanti convergenti sforzi ermeneutici spetta un significato particolare: una verifica dello stato dell'arte, relativamente alla critica slataperiana, che mette perfettamente in rilievo tanto le luci e le ombre di una fortuna, quanto le diverse velocità con cui la critica ha affrontato l'approfondimento dei diversi settori dell'operosità dello scrittore triestino. Riflessione collettiva di particolare interesse anche per l'eterogeneità delle forze coinvolte; e non parlo delle differenti prospettive critiche che hanno visto messi alla prova, nei due incontri di Trieste e di Besançon, i propri strumenti interpretativi. Fatti saggi (o disincantati) dalla crisi delle ideologie sappiamo ormai bene quanto poco senso abbia, in campo letterario, difendere il dogma di una verità come se da essa possa scaturire la parola unica e definitiva su un'esperienza di vita e di scrittura. Mentre è invece la collaborazione di metodologie e il calibrato eclettismo degli approcci che ne può dare il tutto tondo. Ciò cui intendevo alludere era invece la provenienza eterogenea - e in quanto tale, nella dialettica di voci, feconda di risultati - di coloro che hanno partecipato a questi incontri. Studiosi di vecchia generazione si sono incontrati con ricercatori più giovani, critici incardinati nell'Accademia hanno dialogato con intellettuali provenienti dai ranghi dell'associazionismo culturale, Maestri riconosciuti nel campo degli studi slataperiani e della letteratura triestina (Giorgio Baroni, Cristina Benussi, Alfredo Luzi) si sono fatti guida del percorso di neofiti, che da parte loro travasavano nel discorso comune il portato di diverse e non meno interessanti esperienze di ricerca. Per tacere poi delle utili occasioni di confronto tra "scuola" critica francese e italiana, nei limiti in cui di tali si può ancora parlare in epoca di globalizzazione omologante. Del resto è così che la cultura guadagna un effettivo valore sociale, allargandosi oltre gli ambienti più specialistici: si diffonde, forma humus, favorisce inaspettate germinazioni perfino tra i più giovani. Se poi la scuola aiutasse, liberata dalla morsa di penuria dove la costringe l'eterna "emergenza" italiana (per non dire del totale disinteresse a suo riguardo da parte di ceti dirigenti, protagonisti dell'«implacabile percorso di distruzione della scuola» - M. Boscaino), se poi i Media volessero tener dietro cessando di piegarsi alla «drogata e manipolata rapidità in cui tutto si trasforma in spettacolo» (Zanzotto, 1996) ecco che la Letteratura (e non si intendono i troppi Dan Brown della subcultura consumistica) potrebbe risultare veramente spendibile a favore dell'Italia civile (o meglio, da incivilire).
 Comunque, per tornare al tema, l'immagine di Slataper presentata nel volume che riprende il titolo dell'incontro triestino ha, parlando in termini di interpretazione, connotati se non nuovi certo stimolanti: quanto di meglio poteva scaturire da una tradizione critica aggiornata, con tutti i suoi limiti, ai dati dell'oggi. E quindi tappa da cui ripartire, con maggior consapevolezza dei risultati raggiunti e del lavoro da fare. Per entrare più nello specifico va sottolineato che, nel sentire comune diffuso anche in ambienti specialistici, Slataper è quasi solo l'autore del Mio Carso. Libro triestinissimo, certo (e non era del resto quello di scrivere "triestinamente" uno dei grandi impegni che il giovane autore aveva deciso di assolvere?), ma anche facilmente riconducibile alle coordinate nazionali dell'attività letteraria, considerato il suo inserimento nel filone impressionistico - espressionistico del frammentismo vociano.'E la direzione auspicata, in fondo, dal primo critico di Slataper, quel Giani Stuparich, che cosi introduceva nel 1950 la riedizione della monografia degli anni Venti: «l'opera dello Slataper che resiste al tempo», affermava con retro - pensiero crociano, «è l'opera d'arte e il diario. [...] Nel Mio Carso c'è tutta l'immagine viva di lui, trasmessa nella sfera che non impallidisce, nelle Lettere alle tre amiche, dove l'uomo si svela come a se stesso in un intimo diario, c'è il suo formarsi, il suo penare e gioire, l'essenza della sua personalità umana». Finivano in tal modo per restare in ombra l'autore dell'Ibsen, il saggista storico - politico e, nonostante il fermo auspicio, anche l'epistolografo. Settori di indagine più arretrati anche per la relativa inattendibilità dei materiali a disposizione, dal momento che lo stesso Stuparich, a cui si deve la cura degli scritti dell'amico nell'unica edizione a tutt'oggi esistente, operava con una certa disinvoltura sugli inediti, attento a non scalfire quel ritratto eroico di patriota sacrificatosi per l'Italia, di uomo probo secondo modelli e pregiudizi dell'età borghese, che Trieste aveva tanto faticato ad accettare per l'indisponibilità dal notabilato colto della città giuliana a superare l'esplicita damnatio memoriae cui aveva condannato, ben prima della guerra, il giovane ribelle, l'indocile autore delle Lettere triestine. Ci vuol poco a capire dunque che il primo ineludibile compito per chi voglia affrontare oggi il "problema" Slataper e renderne accessibile l'opera nella sua veste autentica a studiosi, persone di cultura, studenti è quello di mettersi con pazienza al lavoro sui manoscritti, in gran parte disponibili per nostra fortuna presso l'Archivio di Stato di Trieste grazie al generoso lascito degli eredi. Solo superato questo scoglio che ben rappresenta, come si capisce, il punto di svolta degli studi slataperiani, ci si potrà applicare ai particolari di un ritratto che appare ancora in molti dettagli sfocato. I saggi qui presentati offrono il destro a una seconda serie di riflessioni, sul terreno specifico della critica letteraria. Da un lato andrà notato il ruolo minimo della psico - critica (in parte rappresentata, ma elegantemente sui generis, dal saggio di Alfredo Luzi), i cui titoli sono oggi particolarmente in ribasso, oltre che per gli antichi pregiudizi della tradizione idealistica, cattolica e marxista, anche per la centrifuga frammentazione della galassia psicanalitica, ma che pure, nel caso di un autore così disponibile, nelle lettere e nel Mio Carso, a lasciar filtrare in superficie gli echi del profondo (si pensi solo alla torsione fusionale e panica del motivo della natura nell'opera più nota, rilevante portato di «voci telluriche» avrebbe detto Debenedetti), potrebbe risultare foriero di utili risultati. Dall'altro - ma forse si tratta solo di un mio personale chiodo fisso - bisognerà rilevare che Slataper, e non solo quello del libro più noto, risulta, nella lettura che prevale, un po' troppo "addossato" a Firenze, ovvero non sempre sufficientemente radicato nel contesto triestino, campo di lotta di opposte ideologie e di antagonistici nazionalismi, come zone di frizione etnica nel corso del "secolo breve". E ciò mentre il tema del confine orientale, "confine mobile" come è stato detto, è diventato, sparite le ragioni concrete del contendere, una vera e propria moda storiografica (con tutto ciò che questo comporta, nel bene e nel male). Nessuno negherà, per altro, che Slataper prenda le mosse da una situazione "provinciale", brillantemente superata proprio per averla elevata a problema; e quindi Firenze come vera soglia di maturazione (e non solo intellettuale). E altrettanto vero però che non si tratta di una provincia qualsiasi, ma di un trivio di razze, lingue e tradizioni in vibrante e spesso aspra dialettica dove, Slataper lo capisce e lo afferma, la Storia mondiale mostra il suo volto più autentico («è meraviglioso e quasi vertiginoso pensare come in questo nostro piccolo angolo di Europa si combattano le forze e i problemi che forse sono tra i più gravi del mondo occidentale d'oggi: germanesimo e slavismo, problema balcanico, egemonia commerciale, avvenire austriaco - e italianità. La grande, piena, ricca, inquieta civiltà latina. Che non può morire neanche di là dell'Adriatico»). Rinviando per tutto ciò ai saggi della raccolta, non resta che dar corso ai ringraziamenti. In primo luogo a tutti gli studiosi che hanno voluto partecipare all'impresa, tanto nelle sue fasi congressuali che nella successiva di elaborazione e stesura dei contributi che qui presentiamo. Quindi alle associazioni promotrici e al loro generoso sforzo economico, ovvero all'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia e al Gruppo 85 Skupina, di Trieste - Trst, cui va aggiunto SVSB Editore, Padova - Trieste e, per l'incontro francese, l'Université de Franche - Comté, a Besançon. Spalleggiati, con vivace disponibilità intellettuale, dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia e dal Centro Studi "Biagio Marin" di Grado. Inutile aggiungere che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il decisivo intervento di Enti finanziatori. Anzitutto la Regione Friuli Venezia Giulia, primo contributore delle iniziative culturali del territorio, e quindi, per questo evento specifico, il Comune di Trieste, la Fondazione CRTrieste e il Credito Cooperativo del Carso - Zadružna Kraška Banka. Un particolare ringraziamento, inoltre, alla signora Gabry Benci che ci ha concesso l'utilizzo del suo ritratto di Scipio Slataper per la locandina dell'evento triestino.
Comunque, per tornare al tema, l'immagine di Slataper presentata nel volume che riprende il titolo dell'incontro triestino ha, parlando in termini di interpretazione, connotati se non nuovi certo stimolanti: quanto di meglio poteva scaturire da una tradizione critica aggiornata, con tutti i suoi limiti, ai dati dell'oggi. E quindi tappa da cui ripartire, con maggior consapevolezza dei risultati raggiunti e del lavoro da fare. Per entrare più nello specifico va sottolineato che, nel sentire comune diffuso anche in ambienti specialistici, Slataper è quasi solo l'autore del Mio Carso. Libro triestinissimo, certo (e non era del resto quello di scrivere "triestinamente" uno dei grandi impegni che il giovane autore aveva deciso di assolvere?), ma anche facilmente riconducibile alle coordinate nazionali dell'attività letteraria, considerato il suo inserimento nel filone impressionistico - espressionistico del frammentismo vociano.'E la direzione auspicata, in fondo, dal primo critico di Slataper, quel Giani Stuparich, che cosi introduceva nel 1950 la riedizione della monografia degli anni Venti: «l'opera dello Slataper che resiste al tempo», affermava con retro - pensiero crociano, «è l'opera d'arte e il diario. [...] Nel Mio Carso c'è tutta l'immagine viva di lui, trasmessa nella sfera che non impallidisce, nelle Lettere alle tre amiche, dove l'uomo si svela come a se stesso in un intimo diario, c'è il suo formarsi, il suo penare e gioire, l'essenza della sua personalità umana». Finivano in tal modo per restare in ombra l'autore dell'Ibsen, il saggista storico - politico e, nonostante il fermo auspicio, anche l'epistolografo. Settori di indagine più arretrati anche per la relativa inattendibilità dei materiali a disposizione, dal momento che lo stesso Stuparich, a cui si deve la cura degli scritti dell'amico nell'unica edizione a tutt'oggi esistente, operava con una certa disinvoltura sugli inediti, attento a non scalfire quel ritratto eroico di patriota sacrificatosi per l'Italia, di uomo probo secondo modelli e pregiudizi dell'età borghese, che Trieste aveva tanto faticato ad accettare per l'indisponibilità dal notabilato colto della città giuliana a superare l'esplicita damnatio memoriae cui aveva condannato, ben prima della guerra, il giovane ribelle, l'indocile autore delle Lettere triestine. Ci vuol poco a capire dunque che il primo ineludibile compito per chi voglia affrontare oggi il "problema" Slataper e renderne accessibile l'opera nella sua veste autentica a studiosi, persone di cultura, studenti è quello di mettersi con pazienza al lavoro sui manoscritti, in gran parte disponibili per nostra fortuna presso l'Archivio di Stato di Trieste grazie al generoso lascito degli eredi. Solo superato questo scoglio che ben rappresenta, come si capisce, il punto di svolta degli studi slataperiani, ci si potrà applicare ai particolari di un ritratto che appare ancora in molti dettagli sfocato. I saggi qui presentati offrono il destro a una seconda serie di riflessioni, sul terreno specifico della critica letteraria. Da un lato andrà notato il ruolo minimo della psico - critica (in parte rappresentata, ma elegantemente sui generis, dal saggio di Alfredo Luzi), i cui titoli sono oggi particolarmente in ribasso, oltre che per gli antichi pregiudizi della tradizione idealistica, cattolica e marxista, anche per la centrifuga frammentazione della galassia psicanalitica, ma che pure, nel caso di un autore così disponibile, nelle lettere e nel Mio Carso, a lasciar filtrare in superficie gli echi del profondo (si pensi solo alla torsione fusionale e panica del motivo della natura nell'opera più nota, rilevante portato di «voci telluriche» avrebbe detto Debenedetti), potrebbe risultare foriero di utili risultati. Dall'altro - ma forse si tratta solo di un mio personale chiodo fisso - bisognerà rilevare che Slataper, e non solo quello del libro più noto, risulta, nella lettura che prevale, un po' troppo "addossato" a Firenze, ovvero non sempre sufficientemente radicato nel contesto triestino, campo di lotta di opposte ideologie e di antagonistici nazionalismi, come zone di frizione etnica nel corso del "secolo breve". E ciò mentre il tema del confine orientale, "confine mobile" come è stato detto, è diventato, sparite le ragioni concrete del contendere, una vera e propria moda storiografica (con tutto ciò che questo comporta, nel bene e nel male). Nessuno negherà, per altro, che Slataper prenda le mosse da una situazione "provinciale", brillantemente superata proprio per averla elevata a problema; e quindi Firenze come vera soglia di maturazione (e non solo intellettuale). E altrettanto vero però che non si tratta di una provincia qualsiasi, ma di un trivio di razze, lingue e tradizioni in vibrante e spesso aspra dialettica dove, Slataper lo capisce e lo afferma, la Storia mondiale mostra il suo volto più autentico («è meraviglioso e quasi vertiginoso pensare come in questo nostro piccolo angolo di Europa si combattano le forze e i problemi che forse sono tra i più gravi del mondo occidentale d'oggi: germanesimo e slavismo, problema balcanico, egemonia commerciale, avvenire austriaco - e italianità. La grande, piena, ricca, inquieta civiltà latina. Che non può morire neanche di là dell'Adriatico»). Rinviando per tutto ciò ai saggi della raccolta, non resta che dar corso ai ringraziamenti. In primo luogo a tutti gli studiosi che hanno voluto partecipare all'impresa, tanto nelle sue fasi congressuali che nella successiva di elaborazione e stesura dei contributi che qui presentiamo. Quindi alle associazioni promotrici e al loro generoso sforzo economico, ovvero all'Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia e al Gruppo 85 Skupina, di Trieste - Trst, cui va aggiunto SVSB Editore, Padova - Trieste e, per l'incontro francese, l'Université de Franche - Comté, a Besançon. Spalleggiati, con vivace disponibilità intellettuale, dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia e dal Centro Studi "Biagio Marin" di Grado. Inutile aggiungere che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il decisivo intervento di Enti finanziatori. Anzitutto la Regione Friuli Venezia Giulia, primo contributore delle iniziative culturali del territorio, e quindi, per questo evento specifico, il Comune di Trieste, la Fondazione CRTrieste e il Credito Cooperativo del Carso - Zadružna Kraška Banka. Un particolare ringraziamento, inoltre, alla signora Gabry Benci che ci ha concesso l'utilizzo del suo ritratto di Scipio Slataper per la locandina dell'evento triestino.
Hanno collaborato alla miscellanea: Giorgio Baroni, Cristina Benussi, Marino Biondi, Elena Bovo, Alberto Brambilla, Bernard Hauteclocque, Miran Košuta, Alfredo Luzi, Livia de Savorgnani Zanmarchi, Fabio Todero, Lorenzo Tommasini e Simone Volpato.
![]() ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
![]()