![]()
RACCONTI DI IDRIA
di Francesco Macedonio
a cura di Walter Chiereghin
postfazione di Fulvio Senardi
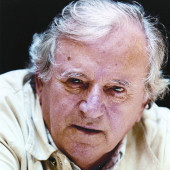
|
|
PUBBLICAZIONI NARRATIVA
RACCONTI DI IDRIA di Francesco Macedonio a cura di Walter Chiereghin |
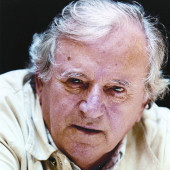 |
ritorna alla pagina generale della NARRATIVA
Mi piacerebbe poter vantare con Francesco Macedonio una lunga, solida, reciprocamente fruttuosa amicizia, del tipo di quelle orgogliosamente esibite dai molti amici che hanno avuto modo in varie forme, a voce e per iscritto, di fregiarsi a buon diritto, dopo la sua scomparsa ma soprattutto prima di tale luttuoso evento, di una prolungata assidua frequentazione con il grande regista teatrale e uomo di cultura. Mi piacerebbe, certo, ma non posso proprio farlo, considerato che Cesco ho avuto modo di conoscerlo di persona, grazie all'intermediazione del comune amico Claudio Grisancich, soltanto un paio di mesi prima della conclusione del suo percorso biografico.
Una manciata di settimane, tre incontri appena nella sua casa di Gorizia, un appartamento al primo piano, distante pochi passi dalla stazione della Transalpina, da quella piccola piazza e da quell'edificio che tanto e tanto simbolicamente testimoniano di un accidentato percorso storico sotto le cui forche caudine è dovuta passare la città isontina, la Venezia Giulia e - logicamente - le nostre stesse vite.
L'oggetto di quegli incontri era - nelle intenzioni almeno - monotematico, dal momento che eravamo lì per leggere assieme i racconti che ora, per la prima volta, sono presentati al pubblico in questo volume. Naturalmente, anche nei troppo pochi incontri che ho avuto con lui, la conversazione debordava spesso da quelle letture critiche che facevamo assieme, Cesco, Claudio ed io, ma erano ogni volta digressioni di pochi secondi, tanto per conoscere qualcosa l'uno dell'altro (scoprimmo così di aver avuto la stessa professoressa di Lettere all'Istituto Magistrale "Scipio Slataper" di Gorizia, l'indimenticabile Maria Cavazzuti, nel caso di Cesco all'inizio e nel mio alla fine della lunga carriera professionale dell'insegnante, consumata quasi per intero nel medesimo istituto scolastico).
Macedonio presentava in quei nostri incontri, anche a un occhio inesperto, inquietanti sintomi della sua malattia: respirava con difficoltà, era ridotto dall'astenia a una prostrazione fisica che gli impediva persino di alzarsi dalla poltrona per salutarci al nostro arrivo oppure per congedarci mentre stavamo uscendo da casa sua. Lavorava, però, con determinazione e assiduità a questi suoi racconti riesumati dai suoi anni giovanili, una rivisitazione degli anni della sua formazione, filtrati attraverso l'obiettivo di un'esperienza umana giunta ormai alla più tarda maturità.
Ci riceveva in una stanza adibita a studio, le due pareti più lunghe quasi per intero nascoste da librerie, dove, stipati su due file per ogni mensola, si potevano vedere i volumi di una cospicua biblioteca: molti classici, soprattutto teatrali, nella collana I Millenni di Einaudi, ma oltre a questi una quantità di altri libri che testimoniavano della versatilità dell'impegno culturale dell'uomo che, semisdraiato nella sua poltrona, continuava a leggere, emendare e rileggere i testi, manoscritti in una quantità di quaderni scolastici vergati da una scrittura corsiva di non agevole lettura, almeno a prima vista. Noi, Grisancich e io, restavamo incantati ad ascoltare dalla sua voce resasi quasi flebile le piccole storie che ci leggeva, avendole in precedenza estratte dai quaderni sui quali, negli anni giovanili, le aveva annotate, come presagisse che quel materiale narrativo gli sarebbe prima o poi venuto utile per fare i conti con se stesso, con la propria vita, mentre questa si apprestava a chiudere la sua lunga parabola riandando, con la memoria e con una scrittura che di momento in momento si faceva più urgente, a quei minimi episodi degli esordi, nel microcosmo di Idria dove un suo alter ego di nome Andrea viveva nei periodi di vacanza, le sue prime esperienze di vita accanto al nonno e quindi a un'altra figura maschile di adulto, Ignazio.
Alcune notizie biografiche sull'infanzia e l'adolescenza di Macedonio, soprattutto riferite alle sue prolungate permanenze a Idria, mi sono state fornite dalle sorelle del regista, Laura e Maria, nelle fasi preparatorie del presente volume. Ho ritenuto opportuno e utile farne partecipe il lettore, riportandone il testo nell'ultima parte di questo stesso libro. Dalle note fornite dalle sorelle mi è stato possibile ricostruire un quadro più nitido del periodo e del luogo entro cui è confinata la trama dei racconti, come pure ricostruire l'identità di alcuni dei personaggi e l'intersecarsi delle relazioni tra loro.
La figura del nonno, centrale nei primi racconti, svapora in quelli successivi; in effetti il nonno materno Valentino, cui il piccolo Pranzi, come era chiamato dai familiari, era molto legato, scomparve nel 1937, quando il bambino aveva appena dieci anni, ("se n'era andato in un giorno d'inverno che nevicava"), costituendo per lui, probabilmente, il primo grande dolore della vita.
Dopo la morte del nonno, la figura maschile di riferimento in questi racconti diviene quella di Ignazio, un contadino affittuario della nonna, che aveva concesso a lui e a sua moglie Micka (si tratta di un vezzeggiativo di Marija) l'uso dell'appartamento al piano superiore della sua stessa casa. Seguendo Ignazio nelle sue attività attraverso campi e boschi, il giovanissimo Andrea impara una quantità di cose della natura che lo circonda, ma anche, per imitazione e per accenni appena percettibili, quanto successivamente gli si farà chiaro in ordine al rapporto con le donne (le "cinciallegre", in ilare fuga davanti a un vecchio irriducibile satiro, incontrate in un bosco di montagna) o quei riti di virile iniziazione alla vita adulta consistenti nei primi approcci al vino e all'alcol, oppure ai piaceri vagamente sadici della caccia.
Tutt'attorno alla galleria dei personaggi che alimentano la narrazione, naturalmente, Idria e i prati, i campi e i boschi che la circondano.
Idria è oggi una cittadina di circa dodicimila abitanti, ubicata in una conca al punto di contatto tra la fine delle prealpi Giulie e l'inizio del Carso. Nota per le miniere di cinabro ormai dismesse, che per secoli hanno costituito la prevalente attività estrattiva della regione, come pure per i suoi pizzi, i famosi "merletti d'Idria" e infine per gli "idrijski ílikrofi", specialità gastronomica della zona, consistente in un primo piatto di ravioli con ripieno a base di patate, serviti normalmente conditi con burro e salvia.
Per il bambino di allora, il viaggio in corriera che da Gorizia lo portava verso Idria "era come entrare in un altro mondo, un mondo con grandi prati, misteriosi boschi, gente buona e all'antica".
Attualmente non esiste nella cittadina una comunità italiana, e anche in passato essa è stata sempre numericamente marginale rispetto alla largamente maggioritaria presenza slovena: nel censimento compiuto dalle autorità italiane nel 1921 risultavano 308 abitanti di lingua italiana su un totale di 10.207. Tra gli italiani di Idria, nel 1931 e nell'anno successivo, era presente con la famiglia anche un bambino di nome Pier Paolo Pasolini.
Nei racconti che sono qui presentati non vi è alcun accenno a tensioni di carattere interetnico, sicuramente presenti in particolare negli anni in cui si svolge l'azione, in presenza di un regime autoritario ossessivamente impegnato ad affermare un'insussistente monolitica identità italiana ai confini orientali e, conseguentemente, all'attuazione di una politica di inclusione forzata delle minoranze linguistiche nel tessuto nazionale che si pretendeva compattamente unitario. Rimane comunque il fatto che Macedonio ha scritto tutti i nomi propri e i toponimi secondo una puntigliosa lezione slovena, anche quando sarebbe disponibile (e quindi più logico in un testo scritto in italiano) un equivalente nella nostra lingua. Così la stessa Idria viene sempre scritta alla maniera slovena di Idrija e a tale scrittura, nella nostra attività di editing, ci siamo volutamente sempre attenuti, per lo scrupolo filologico di rendere i racconti quanto più aderenti alla impostazione che aveva inteso imprimere loro l'Autore.
Un'altra avvertenza di carattere filologico: Macedonio era disponibile ad accettare prontamente suggerimenti che, al termine della sua lettura, gli fornivamo. Nella revisione finale dei testi trascritti al computer, sentiti anche i pareri di amici quali Grisancich e Longo, che come e più di me avevano vissuto da vicino la genesi di quest'ultima fatica di Cesco, ho provveduto con parsimonia a emendare i testi limitando i miei interventi agli evidenti errori di battitura o di trascrizione.
.jpg)
Da ultimo si avverte in questa sorta di premessa metodologica che la sequenza con la quale sono qui presentati i testi, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Autore, è del tutto arbitraria, anche se in linea di principio si è inteso ricreare una sequenza di tipo cronologico, basata sui contenuti dei singoli racconti, nei quali è rinvenibile una traccia che identifica un'evoluzione dei fatti narrati oppure implicita nella psicologia del protagonista che, come si è accennato, descrive nelle pagine che seguono un suo percorso formativo individuabile con relativa facilità.
di Walter Chiereghin
Vuole la saggezza popolare che negli ultimi istanti ci scorra davanti agli occhi il nastro dell’esistenza intera. Qualcosa del genere dev’essere accaduto a Francesco Macedonio (1927 - 2014) quando, con foga inattesa per i suoi novant’anni, si è messo a rivedere e a riscrivere, a pochi mesi dalla morte, pagine abbozzate tanto prima. Macedonio, aggiungiamo per i pochissimi che non lo sanno, era diventato da tempo uno dei registi che importano, uno che la gente applaude, per l’intelligenza delle messe in scena la prima garanzia di successo di una pièce. Sentiva però forse mancargli qualcosa, e che dovesse colmare quel vuoto mettendosi sulla via dei ricordi di infanzia e di adolescenza. Non tanto per aggiungere un’altra fogliolina al suo alloro, che resta ben verde tanto nella storia del teatro giuliano che nel ricordo di tutti; cosa che poi a un uomo modesto e auto-ironico com’egli è stato doveva importare ben poco. Ma come per portare a galla, in un dialogo intimo con se stesso, con le ultime forze rimaste (‘suono sempre, ma suono ognor più piano’, scriveva splendidamente, tantissimi anni fa, Govoni), un riflesso di gioventù, che meritava pienamente l’onore della carta, sulla quale sgorga con colori vivissimi ma emozionalità attenuata, un sogno quasi se non sapessimo quanto autobiografici siano i casi e i fatti che divengono oggetto di racconto.
di Fulvio Senardi
Francesco Macedonio (Idria, 1927 - Gorizia, 2014) è stato insegnante elementare dagli anni dal dopoguerra al pensionamento, ma il suo impegno di educatore non gli ha impedito di coltivare la sua grande passione per il teatro che lo ha condotto a divenire un regista teatrale di prima grandezza nel panorama nazionale, ma anche in quello internazionale, considerata la sua assidua attività nelle principali compagnie di prosa della Slovenia e della Croazia, sia in quella in lingua italiana che in quelle di lingua slovena e croata. Rimasto refrattario alle offerte che lo allontanassero dalla sua terra, pur collaborando in particolare con una compagnia di Bologna, ha agito soprattutto tra Gorizia e Trieste, città quest’ultima dove è stato regista di riferimento per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e successivamente per il Teatro Popolare la Contrada (oggi Teatro Stabile di Trieste), di cui è stato cofondatore. Negli ultimi giorni della sua vita ha ripreso in mano degli scritti memorialistici giovanili per riadattarli in forma narrativa con l’intento di pubblicarli, pagine che ora – a un anno dalla scomparsa – vengono in effetti mandati in stampa.
Regista e autore teatrale, Francesco Macedonio è nato a Idria – una località non lontana da Gorizia – da una famiglia di musicisti. Dopo essersi istruito in vari collegi della zona, è diventato insegnante elementare. L’interesse per il teatro nasce assai presto, anche attraverso gli spettacoli cinematografici e teatrali che egli, ancora ragazzino, ha occasione di vedere a Gorizia. Dopo la fine della guerra, Macedonio fonda a Gorizia una compagnia teatrale per la quale svolge le mansioni di regista. La grande svolta giunge però nel 1967, quando il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia gli chiede di mettere in scena un testo di Vittorio Franceschi, “Gorizia 1916“, interpretato dallo stesso Franceschi. Da allora Macedonio diviene il regista stabile del Teatro del Friuli-Venezia Giulia, dirigendo la famosa compagnia dei “dodici”, gli attori che per numerosi anni costituirono il gruppo di riferimento fisso per gli allestimenti di produzione. Fra gli spettacoli allestiti per lo Stabile, “Sior Todero brontolon” con Corrado Gaipa, “Il mio Carso“, “Avvenimento nella città di Goga” con Gabriele Lavia, “Casa di bambola”, “L’idealista” con Corrado Pani, “Vecchio mondo” con Lina Volonghi, “I rusteghi“, oltre alla fortunatissima trilogia in dialetto triestino di Carpinteri e Faraguna “Le Maldobrie”, “Noi delle vecchie province” e “L’Austria era un paese ordinato”: uno dei successi più grandi nella storia teatrale triestina recente. Nel 1976, assieme agli attori Orazio Bobbio, Ariella Reggio e Lidia Braico, Macedonio fonda il Teatro Popolare La Contrada, del quale è direttore artistico. In tale veste ha messo in scena parecchie decine di spettacoli, spaziando dal teatro in dialetto triestino a quello in lingua italiana, dal repertorio brillante a quello drammatico, sino a numerosi allestimenti per il teatro ragazzi. Ha inoltre curato la messa in scena di alcuni spettacoli per la compagnia dei “Piccoli” di Podrecca e di alcune opere e operette per il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Tra gli allestimenti più recenti, sono da ricordare “El mulo Carleto” e “El serpente de l’Olimpia” di Roberto Damiani ispirati alle opere e alla figura di Angelo Cecchelin, Antonio Freno di Macedonio-Perno, “L’assente” di Bruno Maier, “L’Americano di San Giacomo”, “Un nido di memorie”, “L’ultimo carneval” e “I Ragazzi di Trieste” di Tullio Kezich, “Classe di ferro” di Aldo Nicolaj, “Due paia di calze di seta di Vienna” e “Cosa dirà la gente?” di Carpinteri e Faraguna, “Ballando con Cecilia” di Pino Roveredo, “Ecco un uomo libero” di Tom Stoppard, “I rusteghi” di Goldoni e “I Ragazzi Irresistibili” di Neil Simon e “Zente Refada” di Giacinto Gallina. Si dedica anche alla scrittura drammaturgica, componendo, in collaborazione con Ninì Perno “Quela sera de febraio“, “Un’Isotta nel giardino” e “Antonio Freno”. Sue sono anche numerose commedie espressamente pensate per il teatro ragazzi, come “La vecchia e la luna”, “Bandiera”, “Scarabocchio”, “Dietro la cometa”, “E tutto per una rosa”, “La vigilia di Natale” e, più di recente, “Giro giro tondo”.
Il Piccolo 19.02.2007 – “Francesco Macedonio compie ottant’anni e Gorizia lo festeggia” – Premio alla carriera assegnato al regista dal comune di Gorizia - See more at: http://www.contradateatroragazzi.it/chi-siamo/biografie/registi/francesco-macedonio#sthash.dvs3B74g.dpufRegista e autore teatrale, Francesco Macedonio è nato a Idria – una località non lontana da Gorizia – da una famiglia di musicisti. Dopo essersi istruito in vari collegi della zona, è diventato insegnante elementare. L’interesse per il teatro nasce assai presto, anche attraverso gli spettacoli cinematografici e teatrali che egli, ancora ragazzino, ha occasione di vedere a Gorizia. Dopo la fine della guerra, Macedonio fonda a Gorizia una compagnia teatrale per la quale svolge le mansioni di regista. La grande svolta giunge però nel 1967, quando il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia gli chiede di mettere in scena un testo di Vittorio Franceschi, “Gorizia 1916“, interpretato dallo stesso Franceschi. Da allora Macedonio diviene il regista stabile del Teatro del Friuli-Venezia Giulia, dirigendo la famosa compagnia dei “dodici”, gli attori che per numerosi anni costituirono il gruppo di riferimento fisso per gli allestimenti di produzione. Fra gli spettacoli allestiti per lo Stabile, “Sior Todero brontolon” con Corrado Gaipa, “Il mio Carso“, “Avvenimento nella città di Goga” con Gabriele Lavia, “Casa di bambola”, “L’idealista” con Corrado Pani, “Vecchio mondo” con Lina Volonghi, “I rusteghi“, oltre alla fortunatissima trilogia in dialetto triestino di Carpinteri e Faraguna “Le Maldobrie”, “Noi delle vecchie province” e “L’Austria era un paese ordinato”: uno dei successi più grandi nella storia teatrale triestina recente. Nel 1976, assieme agli attori Orazio Bobbio, Ariella Reggio e Lidia Braico, Macedonio fonda il Teatro Popolare La Contrada, del quale è direttore artistico. In tale veste ha messo in scena parecchie decine di spettacoli, spaziando dal teatro in dialetto triestino a quello in lingua italiana, dal repertorio brillante a quello drammatico, sino a numerosi allestimenti per il teatro ragazzi. Ha inoltre curato la messa in scena di alcuni spettacoli per la compagnia dei “Piccoli” di Podrecca e di alcune opere e operette per il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Tra gli allestimenti più recenti, sono da ricordare “El mulo Carleto” e “El serpente de l’Olimpia” di Roberto Damiani ispirati alle opere e alla figura di Angelo Cecchelin, Antonio Freno di Macedonio-Perno, “L’assente” di Bruno Maier, “L’Americano di San Giacomo”, “Un nido di memorie”, “L’ultimo carneval” e “I Ragazzi di Trieste” di Tullio Kezich, “Classe di ferro” di Aldo Nicolaj, “Due paia di calze di seta di Vienna” e “Cosa dirà la gente?” di Carpinteri e Faraguna, “Ballando con Cecilia” di Pino Roveredo, “Ecco un uomo libero” di Tom Stoppard, “I rusteghi” di Goldoni e “I Ragazzi Irresistibili” di Neil Simon e “Zente Refada” di Giacinto Gallina. Si dedica anche alla scrittura drammaturgica, componendo, in collaborazione con Ninì Perno “Quela sera de febraio“, “Un’Isotta nel giardino” e “Antonio Freno”. Sue sono anche numerose commedie espressamente pensate per il teatro ragazzi, come “La vecchia e la luna”, “Bandiera”, “Scarabocchio”, “Dietro la cometa”, “E tutto per una rosa”, “La vigilia di Natale” e, più di recente, “Giro giro tondo”.
Il Piccolo 19.02.2007 – “Francesco Macedonio compie ottant’anni e Gorizia lo festeggia” – Premio alla carriera assegnato al regista dal comune di Gorizia - See more at: http://www.contradateatroragazzi.it/chi-siamo/biografie/registi/francesco-macedonio#sthash.dvs3B74g.dpufRegista e autore teatrale, Francesco Macedonio è nato a Idria – una località non lontana da Gorizia – da una famiglia di musicisti. Dopo essersi istruito in vari collegi della zona, è diventato insegnante elementare. L’interesse per il teatro nasce assai presto, anche attraverso gli spettacoli cinematografici e teatrali che egli, ancora ragazzino, ha occasione di vedere a Gorizia. Dopo la fine della guerra, Macedonio fonda a Gorizia una compagnia teatrale per la quale svolge le mansioni di regista. La grande svolta giunge però nel 1967, quando il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia gli chiede di mettere in scena un testo di Vittorio Franceschi, “Gorizia 1916“, interpretato dallo stesso Franceschi. Da allora Macedonio diviene il regista stabile del Teatro del Friuli-Venezia Giulia, dirigendo la famosa compagnia dei “dodici”, gli attori che per numerosi anni costituirono il gruppo di riferimento fisso per gli allestimenti di produzione. Fra gli spettacoli allestiti per lo Stabile, “Sior Todero brontolon” con Corrado Gaipa, “Il mio Carso“, “Avvenimento nella città di Goga” con Gabriele Lavia, “Casa di bambola”, “L’idealista” con Corrado Pani, “Vecchio mondo” con Lina Volonghi, “I rusteghi“, oltre alla fortunatissima trilogia in dialetto triestino di Carpinteri e Faraguna “Le Maldobrie”, “Noi delle vecchie province” e “L’Austria era un paese ordinato”: uno dei successi più grandi nella storia teatrale triestina recente. Nel 1976, assieme agli attori Orazio Bobbio, Ariella Reggio e Lidia Braico, Macedonio fonda il Teatro Popolare La Contrada, del quale è direttore artistico. In tale veste ha messo in scena parecchie decine di spettacoli, spaziando dal teatro in dialetto triestino a quello in lingua italiana, dal repertorio brillante a quello drammatico, sino a numerosi allestimenti per il teatro ragazzi. Ha inoltre curato la messa in scena di alcuni spettacoli per la compagnia dei “Piccoli” di Podrecca e di alcune opere e operette per il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Tra gli allestimenti più recenti, sono da ricordare “El mulo Carleto” e “El serpente de l’Olimpia” di Roberto Damiani ispirati alle opere e alla figura di Angelo Cecchelin, Antonio Freno di Macedonio-Perno, “L’assente” di Bruno Maier, “L’Americano di San Giacomo”, “Un nido di memorie”, “L’ultimo carneval” e “I Ragazzi di Trieste” di Tullio Kezich, “Classe di ferro” di Aldo Nicolaj, “Due paia di calze di seta di Vienna” e “Cosa dirà la gente?” di Carpinteri e Faraguna, “Ballando con Cecilia” di Pino Roveredo, “Ecco un uomo libero” di Tom Stoppard, “I rusteghi” di Goldoni e “I Ragazzi Irresistibili” di Neil Simon e “Zente Refada” di Giacinto Gallina. Si dedica anche alla scrittura drammaturgica, componendo, in collaborazione con Ninì Perno “Quela sera de febraio“, “Un’Isotta nel giardino” e “Antonio Freno”. Sue sono anche numerose commedie espressamente pensate per il teatro ragazzi, come “La vecchia e la luna”, “Bandiera”, “Scarabocchio”, “Dietro la cometa”, “E tutto per una rosa”, “La vigilia di Natale” e, più di recente, “Giro giro tondo”.
Il Piccolo 19.02.2007 – “Francesco Macedonio compie ottant’anni e Gorizia lo festeggia” – Premio alla carriera assegnato al regista dal comune di Gorizia - See more at: http://www.contradateatroragazzi.it/chi-siamo/biografie/registi/francesco-macedonio#sthash.dvs3B74g.dpuf
ritorna alla pagina generale della NARRATIVA