![]()
Pubblicazioni Poesia
Caludio Grisancich
> QUADERNO BLU <
Gerografia Sentimentale
Coedizione con il Circolo della Stampa di Trieste
edito nel 2025
ISBN: 9-788894 427653
|
|
Pubblicazioni Poesia Caludio Grisancich > QUADERNO BLU < Gerografia Sentimentale Coedizione con il Circolo della Stampa di Trieste edito nel 2025 ISBN: 9-788894 427653 |
![]() ritorna alla
pagina generale della POESIA
ritorna alla
pagina generale della POESIA
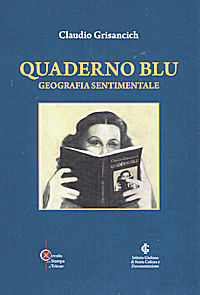 Se per l’ultima raccolta poetica di Claudio Grisancich dovessi proporre un’immagine della Natura, con quel po’ di fantasia che negli anni grigi ancora mi rimane, non troverei nulla di più adatto, credo, della figura della melagrana. Che ha per altro un illustre pedigree letterario: era l’emblema scelto da D’Annunzio per il suo ultimo ciclo narrativo, che si arresta al primo dei romanzi, Il fuoco. Sì, melagrana, per la particolare consistenza del frutto. Grani di polpa tenuti insieme da una buccia resistente, ma ciascuno ben sagomato e separato dagli altri. Ciascuno un piccolo mondo a sé e tutti insieme a formare il frutto fragrante che conosciamo.
Se per l’ultima raccolta poetica di Claudio Grisancich dovessi proporre un’immagine della Natura, con quel po’ di fantasia che negli anni grigi ancora mi rimane, non troverei nulla di più adatto, credo, della figura della melagrana. Che ha per altro un illustre pedigree letterario: era l’emblema scelto da D’Annunzio per il suo ultimo ciclo narrativo, che si arresta al primo dei romanzi, Il fuoco. Sì, melagrana, per la particolare consistenza del frutto. Grani di polpa tenuti insieme da una buccia resistente, ma ciascuno ben sagomato e separato dagli altri. Ciascuno un piccolo mondo a sé e tutti insieme a formare il frutto fragrante che conosciamo.
Nel caso delle liriche di Quaderno blu la buccia che dà tenuta è una forza coesiva che nasce dall’interno, oltre al dialetto naturalmente e alla particolare maniera di plasmarlo. Intendo un pervasivo stato d’animo pacificato e sereno, un sentimento che respirano le singole poesie, tanto da sciogliere, pur così eterogenee, quelle molecole di «germe scuro» che la critica aveva riconosciuto aleggiare nella poesia di Grisancich (la definizione appartiene a Luigi Nacci, 2006, ma anche Franco Brevini aveva offerto, nel 1989, una lettura analoga).
Poi, a guardare più da vicino le singole unità, si avverte la grande autonomia di ciascuna. È infatti una delle meno omogenee (e non è un giudizio di valore) tra le raccolte del poeta. In settant’anni di attività egli ha mostrato una certa predilezione per i cicli organici, sia nella forma più concentrata delle variazioni su un tema (Scarpe zale, Sul ponte della Roja, Est Nord Est - Mantra della bora) sia come insieme più aperto e slabbrato ma tuttavia coerente, in forza di un’unità di sguardo che il titolo contribuiva a chiarire: Dona de pugnai, Crature del pianzer-crature del rider, Inventario, Album.
Quaderno blu ha un’altra orchestra; è come se Grisancich provasse ad accennare, con estro pacatamente ricapitolativo, tutti i motivi che hanno caratterizzato il suo universo. Ciò non vuol dire che manchi una solida presa sui risultati acquisiti. Anzi. Ma ciò piuttosto dal punto di vista formale.
Si pensi per esempio all’inclinazione ad una espressività fatta di versicoli con tutte minuscole e privi di punteggiatura; così totalmente impoveriti nei segnali di sintassi da rendere possibile anche a un lettore dialettale il rischio dell’anfibologia. E sono “versi pici” (il sintagma è caro al poeta, ma, a volergli dare troppo credito, porta fuori strada, ovvero a ridosso di Giotti) misurati ad occhio, al di qua di ogni prosodia (come già in Album e nelle sezioni dialettali di Gente mia). Tanto che in paio di casi Grisancich spezza la parola tra verso e verso come se glielo imponesse «lo fren dell’arte» per dire con «quel dai Diese Giorni» (Noventa). Ed è invece un beffardo gioco di sillabe, che il triestino pratica con un filo di ironia.
Fatto sta che con questo artificio Grisancich da un lato riafferma la natura orale dell’espressione poetica (sono liriche da fruire nell’ascolto più che alla lettura), collocandoci nella posizione di pubblico in platea come quei ferraresi della corte estense ai quali, come a provare la tenuta del poema, messer Ludovico leggeva passi del capolavoro in gestazione (per non parlare dei modi di trasmissione della poesia rituale presso popolazioni pre-alfabetiche). Nella raccolta se ne incontra una chiara allusione in una formula che vale anche come inequivocabiole rimando a Saba, e prima ancora a Petrarca, di cui il Grande Triestino conserva il verbo ma trasformndo il “voi” cristiano e comunitario in un “tu” laico, fraterno e colloquiale; e Grisancich dietro: «ti che ‘desso te me ‘scolti», Cavana.
Dall’altro lato è un sigillo di possesso; dell’universo poetico triestino, in primo luogo, in virtù di settant’anni di fedeltà all’espressione lirica dialettale, dei cui riti di parola vernacola Grisancich è indiscutibilmente il massimo officiante: le dialecte c’est moi! Un dialetto stabilizzato su un registro medio, che evita, più di quanto non fosse nelle prime raccolte (dove si notava la tendenza a una lingua intesa come prezioso reliquiario di modi antichi e di espressioni semi-cancellate), la varietà del triestino “negron” (per dire con Mario Doria, il massimo filologo della lingua nostra), ovvero quello sguaiato e volgare dei ceti più disagiati, ma nel tempo stesso invadente e appropriativo, per come fagocita anche soggetti del tutto estranei alla realtà locale sulla quale esercita un ovvio diritto di possesso, convogliandoli in un universo Trieste-centrico (aveva cantato Bach, in LA MISURA DEL CANTO, Conchiglie, 2010, qui l’america, hollywood, milesetecentonovantratre, napolion, franz kafka, con un aggancio per l’appropriazione dialettale o nel mondo dei ricordi personali, o in qualche esile appiglio tematico: il cavallo lipizzano di Napoleone, la giornata di Kafka a Trieste).
Il dialetto sa dire, se non teme di afferrare il mondo dalla parte della lingua, ed è capace di far sue, come un tempo, tutte le cose. Grisancich non esercita un’ossessiva furia di nominazione, ma una violenza gentile che delimita una zona dialettale che va ramificandosi, su spunto autobiografico o culturale, senza cedere un solo angolo di territorio a quell’italiano, che comunque a Trieste pur imbastardendosi non appena tocca terra sul molo Audace (e scopre un mondo dove il dialetto, magari “rezentà” gode di ottima salute), pure avanza inesorabilmente alla conquista di molti spazi del dire. Aggiungo domandandomi: in un mondo di lingua che, sull’onda dei Media, ha smarrito l’idea di verità e di competenza, promuove la reificazione dell’uomo e la mercificazione del reale attraverso la pubblicità, si prostituisce tra propaganda e frivolezze a sordidi poteri forti, si lascia sfigurare da rasoiate di “italese”, accoglie parole-slogan che virano verso l’insignificanza (“populista”, per es.), necrotizza la creatività diffondendo formule inespressive, non sarà il dialetto fruttuosamente “sedizioso”?
Una trentina d’anni fa Stefano Giovanardi (Poeti italiani del secondo Novecento) valutando la poesia nelle forme storiche del nostro tempo indicava una strada «difficile e contraddittoria»: elaborare uno strumento di rappresentazione della realtà sotto specie negativa, drammaticamente problematico e insieme di fedele registrazione delle antinomie. Se accettiamo questa messa a fuoco mi pare evidente come la parola dialettale si mostri particolarmente capace di aggirare (come difesa, come mistificazione? – scelga chi può) le forche caudine intellettualistiche e di disperata negatività che le premesse di Giovanardi presuppongono.
Chi ci legge avrà notato come siano scivolati nel discorso i nomi di Giotti e di Saba. Siamo a Trieste e sui gioghi, un po’ selvatici, dell’Olimpo locale (hanno iniziato a vederli anche da lontano, facendone una bella occasione di marketing). Da qui non si scappa. Ora, in questa silloge più che altrove Umberto Saba è un eco persistente. Di un’occorrenza si è già detto. E poi c’è una limpida e voluta traccia di Avevo, in Caffè Garibaldi («[…] a dir che sempre la cità / el poeta col canto la ligò a / l’Italia») e le «tristezze molte» di Tre vie, in Trieste, poesia che va di corsa come a sfidare Cergoly (che però ha un acceleratore futurista …) Due volte è il poeta stesso che viene chiamato in causa, mentre sosta al caffè, e poi – il quadretto è bellissimo – mentre incrocia un ragazzino sulla scalinata di via Ciamician; l’occasione, suggerisce Grisancich, è fornita da una famosa fotografia, ma non sarà attiva, magari sub limine, una suggestione di Campionessa di nuoto, la fanciulla dalla «bella bocca altera / che sposò la tua aurora alla mia sera»?
Tuttavia il caso più interessante è sicuramente quello di tre viuzze («a trieste se verzi tre viuzze / co’ i nomi che no’ ga corona»). Il referente sabiano è tanto esplicito da non doverne scrivere. Non credo che Grisancich senta per Saba nulla di diverso che affetto e rispettosa stima di discepolo. Eppure qui il maestro è preso per il naso (e insieme omaggiato). Non solo le vie di cui si tratta sono insignificanti ed anonime ma è totalmente reciso quel legame ombelicale che fa delle vie sabiane l’espressione concreta e calda di un’esistenza di spine e di rose. La tensione esistenziale, il pathos di partecipazione e angoscia, il dono d’anima di quella poesia è volutamente dissolto in una girandola di figure, siamo al limite della filastrocca, tanto da far pensare all’ironico Élouard (attenzione!, il surrealismo non è fuori portata per l’ispirazione di Grisancich: ne registriamo anche qui una bella impronta, e di nuovo a ridosso di «via de le ombrele», nella storiella di Poldrugo). Viuzze dunque, e fatte di niente. Non c’è ombra di timore reverenziale. Grisancich può colloquiare con Saba guardandolo ad altezza d’occhi. Della stessa pasta, no? Il poeta di Lina ne sarebbe, forse, infastidito. Da parte mia plaudo e sorrido, ricordando anche una lirica di Storia di Gino, in Gente mia, 2019, dove la celeste consorteria dei poeti di Trieste viene così simpaticamente delineata: «[…] el / varda fora el mar lontan la cità che / soto casa sua se distira l’istessa de / umberto saba de virgilio giotti de anita / e mia el se disi morsicando el pomo» (de meza matina, una lirica del 2016 (mi sbaglio o c’è un riflesso, nella indicazione triadica, della poesia con cui Giacomo Noventa rivendicava il suo pieno diritto a scrivere in dialetto: «Parché scrivo in dialeto»?)
Omaggio dunque. E che vale anche come confessione identitaria. Specifica però, non indeterminata. Nonostante i “versi pici” di cui si è detto – ma è soltanto una formula che piace – e la triade nominata in de meza matina, Grisancich è profondamente, intimamente sabiano. La perfezione quasi senza tempo di Giotti gli è estranea. Quell’aura di classicità (né ostentata né boriosa, si badi), quel monolinguismo così coerente nel suo grigiore riverberante è lontanissimo dall’impasto misto, spurio, terroso che non teme le cadute, come non temono i “vuoti d’aria” (qui è Saba) le sillogi maggiori di Grisancich. «Un poeta si sporca nella vita con tutto se stesso», ha confessato a Luigi Nacci pellegrino in Parnaso. Un «inalterabile fondo popolano», i «particolati minuti, umili e precisi», i «tocchi di realismo», «la simpatia» che si scioglie in una spesso solo implicita «solidarietà» con il prossimo, quella dell’ homo sum et nihil …, sono qualità che gli appartengono. E le abbiamo definite con espressioni tratte tutte dal saggio solariano di Debenedetti dedicato appunto, nel 1928, a Umberto Saba. Il quale, come leggiamo in Storia e cronistoria del ‘Canzoniere’, rivendicava il valore, fra le altre qualità, della «prosaicità» e dell’«epicità» della sua poesia. Ovvero la capacità di cantare figure e raccontare fatti con un linguaggio un gradino più basso di quello artefatto dei cenacoli di letterati (intendendo, con un filo di malizia, i coetanei della «Voce», che pure per lui un po’ si erano spesi), modellando versi che, cito testualmente «non si vedono», per la forma pura ma non altisonante.
È un tema caro a Grisancich e ribadito con chiarezza estrema. Così si legge in Scarpe zale altre cose (2000) rivendicando una precisa linea di poetica: «Parole / che no ga corona in testa. / Parole / raso muro … come altre, sì / Le te ciol via per man e in quale / storie le porta drento …!» (per diventare poi, in Album del 2013, «dir le robe co’l suo nome»). Nella poesia sbarazzina di cui si è detto, la qualità dell’essere “scoronata” è trasferita alle viuzze, ma mantiene, per traslato, il suo carattere poetologico più complessivo. E comprende forse anche un scintilla di quella pacata meraviglia che ha sempre a che fare in Grisancich con la riscoperta del mondo attraverso la poesia e con la parola che lo ribattezza (giusta l’idea pascoliana del poeta come «fanciullo eterno, che vede tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta»)
Ma ora un passo indietro. Si diceva dei sentimenti che animano le poesie della raccolta. Non vorrei annoiare il lettore (che sa benissimo, per altro, che le prefazioni si leggono dopo o si saltano), ma un inventario va almeno abbozzato. Troviamo un bel mannello di poesie ironiche e scherzose; Grisancich lettore di Giovenale? Non saprei; se manca la denuncia della cattiveria umana, che dà l’asprigno ai versi del latino, c’è una stessa totale assenza di moralismo. Grisancich sa far ridere e sorridere. Nessuna pretesa di raddrizzare le gambe ai cani, come declama Don Abbondio a giustificazione della propria ignavia ma una smorfietta divertita, con una torsione di ironia cui dà pepe un po’ di cattiveria, ma appena appena disegnata.
Altrettanto numerose le poesie di radice autobiografica: il sé bambino, soprattutto (il piccolo Claudio), che ritrova anche in questa raccolta le figure della madre e del padre. E con quest’ultima il recupero del «camion», figurazione mitica di Grisancich affabulatore, l’oggetto che trasferiva sul padre agli occhi del piccino gli attributi di potenza e grandezza (ma l’adulto ha capito ormai quanto quel camion fosse un peso faticoso da portare, una pena di Sisifo che condannava ad un continuo esilio dalla moglie, dalla casa, dagli affetti); oltre che una delle rare concessioni a una certa modernità da parte di una poesia che curiosamente ristabilisce una soglia di «dicibile poetico» (così Luigi Blasucci una ventina d’anni fa, notando quanto Montale avesse contribuito a includere nella poesia la quotidianità più trita in funzione lirica e non “comica”, completando un processo iniziato, con segno anti-petrarchesco, nell’Ottocento). In realtà Grisancich non dà l’ostracismo ai piccoli oggetti di ogni giorno (Blusucci citava la sveglietta …), si pensi soltanto a «bicicleta, «orologi» (tanti, e pure nella forma «oroloi», con oscillazione caratteristica in Grisancich, anche – caso cruciale per il valore socio-culturale ed estetico del dato generazionale – tra «zoventù» in Dona de pugnai, e il posteriore , sempre praticato, «gioventù»), e poi «radio», «el fero» [da stiro], «motocaro», «auto», «moto», «ordegni», «sina», e qualche altro lemma solo a rovistare.
Non poco dunque, a guardare bene. Resta il fatto che la modernità tecnologica, insieme nostro mondo della vita e condizione cruciale della contemporaneità, non ha diritto alla presenza, o assai raramente e mai in posizione forte. Frequentissimo il treno, (ma, insomma, è già carducciano!) mentre il mondo intanto va in aereo, in auto, in motoretta, in bus, in metropolitana, in Tram de Opcina (pardon, andava), si scambia messaggi e fotografie al computer, telefona ossessivamente con cellulari che presto ci impianteranno nel capo, conserva in frigorifero, cucina con Mambo Cooking, riscalda al micro-onde (altro che lo «sparghert», di Inverno, mentre scende la luce dall’abbaino e papà si appresta di nuovo a partire), ascolta magari in mode random la musica sui CD (mio nonno avrebbe interpretato: Corps Diplomatique).
C’è una prima ovvia ed evidente ragione formale: sono oggetti che il dialetto ospita, lessicalmente parlando, senza aver potuto farli propri. Con “television” ci ha provato, la morfologia dà un aiuto, ma forno a micro-onde, per dire? Si aggiunga che la tradizione lirica italiana configura un universo ricco di emozioni e sentimenti, ma povero di concretezza materiale. Uno spirito selettivo che ha operato con severità, tanto da giustificare l’entusiasmo di Ungaretti che nel 1927 (Commemorazione del futurismo) esclamava: «Marinetti ha dunque il merito […] d’aver scorto per prima il posto nella vita, anche estetico che, a tutta carriera, sta facendosi la macchina».
Marinetti, va da sé, è un caso estremo; e Grisancich, dal canto suo, non deflette dalla costante più tradizionale. Decisiva mi pare però la delimitazione di uno specifico cronotopo, che individua una preferibile area socio-culturale di spazio-tempo in cui il dialetto faceva da padrone. Vediamo in Quaderno blu: da un lato, a circoscrivere il campo, Prima del quattordici («coss che non iera el mondo / prima del quattordici […] / iera i versi pici de virgilio / giotti […] fora de café speci / svevo s’impizzava l’ultima / sigareta […]»), dall’altro gli anni cinquanta dell’adolescenza (vardar de le finestre, «n’i ani zinquanta del novecento / se stava ‘ncora vardar in strada / de le finestre la gente che pasava») e del salotto di Anita Pittoni, vera “scena primaria” del giovanissimo poeta e investitura per un futuro al servizio della Musa (da qui l’insistenza con la quale Grisancich tematizza i martedì de Anita, poesia presente in Quaderno blu insieme al tematicamente analogo: a l’antica mormorazione, riprendendo lo spunto di per ‘n’oradela, della raccolta Storia de Gino di Gente mia, 2019). È tra questi elastici Scilla e Cariddi novecenteschi che Grisancich colloca l’età dell’oro del dialetto – e di una Trieste sempre rimpianta come un’Itaca ormai negata – che continua a riverberare anche quando l’affabulazione trascina il presente nel suo vortice, impedendo ogni espressionistico trasalimento dentro la fiumara della modernità e marcando invece con impronta ben netta la tavolozza espressiva.
È sicuramente in Album che Grisancich ci ha offerto la più partecipata elegia di un “mondo antico” che ha piegato il capo di fronte a una realtà gremita dei luoghi e degli oggetti del consumo e la cui natura alienante è difficile non percepire. Il mondo di Album – l’infanzia cantata con un filo di rimpianto per il microcosmo di via San Michele dove Grisancich cominciava a inventariare i fenomeni del mondo con attenti e prensili «oci de puto» (Biagio Marin) – è, rispetto ad oggi e con tutta la scarsità di beni di quell’aspro Dopoguerra, teneramente umano, forma tangibile e vissuta del comunitario: «l’edicola», «l’osteria», l’«emporio de biancheria», il «negozio de tendagi», «el tabachin», «la salumeria» rendevano vivo di incontri e relazioni pur nella quotidianità più normale un rione oggi prosciugato dalla gentrificazione, dalla colonizzazione turistica, dalla grande distribuzione. Ambiente, allora, dai bagliori caldi, anche nelle più fredde giornate di inverno.
È stato lì, per altro, che la poesia di Grisancich ha conquistato quella stabile vocazione popolare – Brevini ha parlato di una vicinanza a Caproni – che ha tenuto il poeta sempre distante dai fondali opulenti e borghesi su cui si è esercitata quasi tutta letteratura triestina (Italo Svevo, per esempio). Prodotto splendido, intendiamoci, della città-azienda.
La fine della storia declamava con una formula allora fortunatissima un sociologo negli anni stessi di Bora zeleste. L’annuncio suonava trionfale, ma ha scandito le fasi di una desertificazione della vita che è andata di pari passo con la caduta delle grandi narrazioni che davano senso e valore di Storia all’occasionale e al transitorio. Come rileva una lirica pur scarsamente politicizzata come questa (a livello esplicito almeno): bianco e nero di Album, 2013 e qui primo magio: «largo pestalozi iera marea de popolo / operai omini done e fameie de giovini / coi fioi tignudi su le spale el rosso d’i / garofani puntai in peto e le bandiere / rosse che s'ciocava in quel largo de / trieste dove la bora refola più forte / avanti pian vegniva la marea "bandiera / rossa" cantando una nova primavera / in fondo del corteo ‘toio fior’ un fià / restà putel co’l garofano in man anca / lu’ cantando "avanti popolo"». Toio Fior rispunta da LA STORIA DE STA ZITÀ di Bora zeleste, come a marcare, fantasma di una stagione perduta, l’“indietro popolo” di questi anni, con tutto ciò che ha significato per le nostre vite. Senza diretta compromissione partitica, da parte di Grisancich, ma con una appassionata perorazione per l’Umano.
Vorrei infine segnalare un terzo settore (chiarendo il valore strumentale di queste partizioni in un universo di parola di liquide intersezioni), quello delle poesie sull’amore, visto dalla parte del cuore e dei sensi, per scindere l’eros, a favore di una chiarezza d’analisi, in due lingue della sua unica fiamma. Nel segno del trasporto sentimentale e, in vari incroci, delle avventure del corpo, dove colpisce il rimando anche sfrontato alle cose del sesso, quella soglia di prossimità all’infinito per chi è poco incline alla metafisica. Qui, in generale, prende sostanza una ricca complessità di sentimento: se da una parte viene raccontato il maschilismo esuberante dell’uomo conquistatore, dai turbamenti adolescenziali al bisogno di sfogo del maschio adulto, dall’altra, nelle liriche dedicate al mondo femminile (e sono parte consistente della raccolta) risalta la valorizzazione della donna in una Laude piena e senza ombre (in genere sul tasto della vita sprecata, con ritrattini alla Hopper in interni di solitudine e malinconia); mentre non poche poesie alludono, con un ritegno reso certo ineludibile dalla torsione autobiografica, alle tenere stagioni dell’amore romantico. E in tutte queste figurazione Grisancich ritrova una porzione di se stesso, l’uomo innamorato, il seduttore intraprendente e, con monellesca trasgressione che fa tanto anni Cinquanta, il ragazzotto che vorrebbe scoprire la “carne”, cedendo magari alle lusinghe dell’amore prezzolato; quel rito di passaggio che segnava, per altre generazioni, l’ingresso nell’età adulta ma che per il poeta, come osserva ironicamente ne i casini di Album, «squasi ‘rivà el momento / ch’i gavessi podesto eco / ch’i li gaveva serai […]».
Delicatissimo nell’alludere agli sbandamenti del cuore, come diretto nel dare il nome alla “cosa” (ma dove il “negron” ma autoctono taconar e derivati: «taconera», documentato in solo e sempre babe, Storia de Gino, in Gente mia, lascia posto al più italianizzante ed “educato” «ciavada», 5 occorrenze di cui 3 in senso figurato). Il dialetto non ha paura di evocare l’immediatezza del βίος, quello che la lingua non sa dire perché si porta dietro, come un’ombra traditrice, un secolare bagaglio di censure. A Trieste, dove il dialetto è vivo, in un contesto di diglossia tendenzialmente paritaria, la parola interdetta (ma che si infila dappertutto) mantiene una sfumatura di senso popolare e provocatoria, di sfida al parlare “come si deve” dei quartieri alti. Quelli di «raccatta il brando» di Bobi Bazlen.
Prima di chiudere un consiglio anche a lettori con scarsa familiarità col dialetto: un suggerimento di lettura segnalando alcune poesia più intense dove il migliore Grisancich dà piena prova del suo estro. Inclassificabili perché sopra e oltre le categorie. Veri pezzi d’antologia che sgorgano con la naturalezza del dire, senza il proposito di “capolavorare” (ma sono sicuro che ciascuno potrà comporre un suo canone eletto): el pan, martedì di anita, el cafè, le done triestine, cavana. Con Ettore e Giacomo, quest’ultima, sotto il cielo un tempo color cobalto, a dar luce a quella leggenda-verità della città letteraria in cui anche Grisancich si ritaglia, per virtù di poesia, il suo proprio medaglione.
Concludendo, un tentativo di bilancio complessivo, ritoccando magari anche vecchi giudizi provvisori espressi da chi scrive. Nell’arco lungo di una vita di poeta, una prima, protratta fase di riconoscimento e di impetuosa affermazione di sé: la conquista del mondo, la gioia di vivere, la scoperta della donna, le corse nella bora (parola assolutamente rappresentativa di questo stagione); autoritratto generazionale stilato con un’enfasi che ricorda Slataper. Poi un momento di disorientamento quanto ai fondamenti di poetica (che culmina nell’abbandono del veicolo dialettale a favore della lingua, che rimarrà in seguito una delle possibilità praticate) e insieme di ripiegamento introspettivo, con un apice a metà anni Settanta. Quindi la riscoperta di sé come cantastorie, voce di una comunità: è la “terza stagione”. Un mondo poetico di figure, aneddoti, racconti, narrativo piuttosto che lirico-elegiaco, intonazione che rispunta negli squarci di rammemorazione e rende irriducibile alla semplificazione una espressività ricca di accordi e suggestioni. Una poesia che schiva il sublime, da sempre impossibile sogno d’arte dell’era borghese, ma ci fa incontrare l’Uomo nell’umile-ambizioso ascolto della voce del mondo.
Fulvio Senardi
Presidente dell'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione.
![]()
![]() ritorna alla pagina generale della POESIA
ritorna alla pagina generale della POESIA
![]()