![]()
LA GIOVINEZZA DI IVO
di Nino di Giacomo
|
|
PUBBLICAZIONI
NARRATIVA
LA GIOVINEZZA DI IVO di Nino di Giacomo |
![]() ritorna
alla pagina generale della NARRATIVA
ritorna
alla pagina generale della NARRATIVA
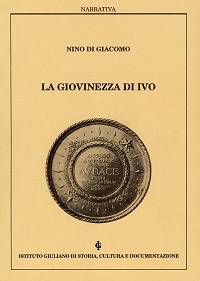 Nella
letteratura triestina del Novecento ha una parte cospicua la cosiddetta "letteratura
di guerra", con riferimento, soprattutto, ai due conflitti mondiali. Per
quanto riguarda il primo, sono da citare almeno il romanzo Ritorneranno
di Giani Stuparich, che si collega, formando una sorta di trilogia, a Colloqui
con mio fratello e a Guerra del '15; e la raccolta di liriche di
Giulio Camber Barni intitolata La Buffa. E per ciò che concerne il secondo,
Ritorno da Poggio Boschetto di Manlio Cecovini e La traccia sul mare
di Falco Marin. In questo ben definito filone letterario si inserisce il romanzo
La giovinezza di Ivo di Nino Di Giacomo; ma occorre tenere presente che,
se per gli autori dianzi ricordati, la guerra è stata un'esperienza vissuta
in prima persona, per Di Giacomo è stata essenzialmente un pretesto o
un'occasione narrativa.
Nella
letteratura triestina del Novecento ha una parte cospicua la cosiddetta "letteratura
di guerra", con riferimento, soprattutto, ai due conflitti mondiali. Per
quanto riguarda il primo, sono da citare almeno il romanzo Ritorneranno
di Giani Stuparich, che si collega, formando una sorta di trilogia, a Colloqui
con mio fratello e a Guerra del '15; e la raccolta di liriche di
Giulio Camber Barni intitolata La Buffa. E per ciò che concerne il secondo,
Ritorno da Poggio Boschetto di Manlio Cecovini e La traccia sul mare
di Falco Marin. In questo ben definito filone letterario si inserisce il romanzo
La giovinezza di Ivo di Nino Di Giacomo; ma occorre tenere presente che,
se per gli autori dianzi ricordati, la guerra è stata un'esperienza vissuta
in prima persona, per Di Giacomo è stata essenzialmente un pretesto o
un'occasione narrativa.
Tuttavia La giovinezza di Ivo non è soltanto un romanzo di guerra, ovvero della nostra occupazione della Jugoslavia insieme con gli alleati tedeschi (1941 - 1943): è anche, infatti, la storia di un amore, quello di Ivo Giorgi e della coetanea Maria Luisa (o, secondo un gusto esoticheggiante allora diffuso, Marilù) Giannini, nato sui banchi del liceo e sviluppatosi negli anni immediatamente successivi; e un esame di coscienza del protagonista, che viene rivedendo le sue posizioni nei confronti del fascismo, della Jugoslavia e della lotta partigiana esplosa in quel territorio. Questi tre motivi si intrecciano e si condizionano reciprocamente nel romanzo, determinandone la dinamica, armoniosa struttura.
Nell'amore di Ivo e Marilù si uniscono sentimento e sensualità (e quel po' di sesso che era allora consentito dal perbenismo borghese); e ribadiscono la sincerità, la solidità e la profondità di un intenso e quasi sempre appagante legame affettivo. Anche perché Ivo, pur essendo slavo da parte paterna, comprende perfettamente la sua ragazza. E questa, benché figlia di un gerarca fascista, riesce a dimenticare e a superare certi grossolani pregiudizi antislavi assorbiti in famiglia e a capire lo stato d'animo del fidanzato: uno stato d'animo tormentato e contraddittorio, perché Ivo, per quanto fascista di convinzioni e ufficiale italiano nella campagna di Jugoslavia, entra a poco a poco in crisi e si avvicina sempre più, anche tramite l'amore per qualche ragazza slava, ai partigiani contro cui combatte, mostrandosi solidale con loro, prendendone, quando può, le difese e aiutandoli in momenti difficili e pericolosi. Qualcosa di simile, giova avvertire, è ravvisabile nella Traccia sul mare di Marin; il quale, ufficiale - come Ivo - nella Jugoslavia occupata dalle truppe italiane e tedesche, si persuade, con sempre maggiore chiarezza, che i suoi sentimenti fascisti si vengono gradualmente indebolendo e dissolvendo; e che egli non può sottrarsi al "fascino" dei "ribelli", intenti a lottare per la loro patria e la loro libertà.
Ritornando a Maria Luisa conviene rammentare che lei crede
sempre meno all'immancabile vittoria dell'Asse; non desidera, molto saggiamente,
che Ivo diventi un "eroe"; e si accontenta di un amore tranquillo
e sereno, onestamente "borghese", in un mondo ancora sconvolto dal
conflitto, ma ormai prossimo a uscire dal tunnel della guerra. La vicenda amorosa
di Ivo e Marilù si manifesta in una molteplicità di episodi che
chiariscono i loro stati d'animo e, più vastamente, la loro specifica
condizione esistenziale. Penso, in particolare, alla gita in piroscafo nella
località balneare di San Nicolò e ai loro approcci erotici in
una cabina, descritta con realistica, vereconda naturalezza anche in certi momenti
d'incontenibile accensione sensuale e passionale (ed è questa una delle
scene più belle e audaci del romanzo). Al viaggio in macchina a Rifembergo,
che consente a Marilù di accostarsi con simpatia al mondo slavo. Al "festino"
in casa Giannini, con lo scontro, insieme ideologico e verbale, tra Ivo e il
fascista Walter Hòlzner, ufficiale di Marina visceralmente avverso agli
slavi. Al ritorno di Ivo, ufficiale in Slovenia, a Trieste per una breve licenza
e alle giornate trascorse con Maria Luisa tra impeti d'amore e forzosi, non
facilm ente
controllabili ritegni e rinunce. E all'incontro finale di Ivo, rientrato dopo
l'8 settembre 1943 e dopo il disfacimento del nostro esercito nella sua città
occupata dai tedeschi, con Marilù sul molo Audace, presso la bronzea
bitta con la "rosa dei venti", dove si sono scambiati il primo bacio
e dove si sono visti molte volte in un recente passato. Anzi, la rosa dei venti
sembra essere il simbolo stesso dei venti di guerra che soffiano violenti in
quegli anni tremendi; e che tuttavia non riescono a intaccare l'amore dei due
giovani, punto fermo e irrinunciabile della loro esistenza.
ente
controllabili ritegni e rinunce. E all'incontro finale di Ivo, rientrato dopo
l'8 settembre 1943 e dopo il disfacimento del nostro esercito nella sua città
occupata dai tedeschi, con Marilù sul molo Audace, presso la bronzea
bitta con la "rosa dei venti", dove si sono scambiati il primo bacio
e dove si sono visti molte volte in un recente passato. Anzi, la rosa dei venti
sembra essere il simbolo stesso dei venti di guerra che soffiano violenti in
quegli anni tremendi; e che tuttavia non riescono a intaccare l'amore dei due
giovani, punto fermo e irrinunciabile della loro esistenza.
Un'altra componente del romanzo di Di Giacomo è costituita dalla partecipazione di Ivo alla conquista della Jugoslavia. La quale si manifesta in tutta una galleria di personaggi: ufficiali dell'esercito e della milizia, per lo più in aspro contrasto tra loro; sottufficiali e attendenti; soldati talora ridotti a graziose, simpatiche macchiette, con le loro storpiature dialettali della nostra lingua e di quella slovena; tedeschi arruolati nella Wehrmacht e nelle S.S.; e partigiani combattenti e ragazze che li affiancano coraggiosamente, anche a rischio della vita, nelle loro azioni. Con i personaggi, maggiori, minori e minimi, gli ambienti: caserme, sedi di comando, abitazioni requisite dagli occupatori; e gli scontri armati tra gli opposti schieramenti, consistenti specialmente, da parte jugoslava, in operazioni di guerriglia, attentati, agguati, sabotaggi, e perciò difficilmente controllabili ed evitabili. Di Giacomo delinea un quadro ampio e complesso della lotta in Jugoslavia, mostrando non solamente una singolare perizia narrativa, ma anche la capacità di imprimere alle vicende un ritmo incalzante e concitato, alternando i toni idillici e affettuosi di qualche fugace incontro d'amore a quelli drammatici e tragici degli scontri bellici; e gli accenti distesi e sereni, propri di un'esistenza che bene o male continua pure durante la guerra, a quelli marziali, talvolta ironici e comici, umoristici e parodistici, che sottolineano efficacemente la vita nei comandi e nelle caserme.
Naturalmente Ivo, coinvolto nell'impresa bellica, cerca di destreggiarsi meglio che può e di "arrangiarsi", non venendo però mai meno alla sua dignità e ai suoi doveri di ufficiale. Ma assai più della sua vita esteriore conta la sua vita interiore, ossia quella costante analisi introspettiva in cui si impegna per chiarire a se stesso le ragioni e i fondamenti, sempre più deboli e assaliti dal tarlo del dubbio, della sua condizione di uomo e di combattente. Il bilancio del suo protratto, rigoroso esame di coscienza è fallimentare: al fascismo, infatti, egli crede sempre meno, e non perché portato da natura a posizioni scettiche e pessimisti che, sì invece perché non può non tenere conto della lezione amara e deludente degli avvenimenti, piccoli e grandi, cui assiste; sicché perviene a poco a poco a una forma larvale ed embrionale di antifascismo. Inoltre egli si rende conto, in pieno accordo con Marilù, che la guerra è inevitabilmente perduta. Di qui il suo "grande salto", ovvero la sua scelta definitiva suggerita o, meglio, imposta dalle vicende belliche e dalle loro implicazioni politiche e ideologiche; e il suo avvicinamento ai "nemici", non più ritenuti tali. Una conversione o, meglio, uno svolgimento etico - politico non privo di perplessità (e di traumi), ma sostanzialmente coerente. A un certo momento l'amica slovena Nada dice a Ivo che è nato non per combattere, ma "per pensare e capire gli altri": per comprendere, cioè, la realtà nel profondo, al di là delle barriere erette dagli uomini e dai loro dissennati odi etnici e politici; e, si può aggiungere, per capire bene sé medesimo, come si deduce dalle numerose pagine autoanalitiche del romanzo.
In questo senso Ivo, impegnato in un'inquieta, coraggiosa e sofferta ricerca di identità, è un personaggio tipico della letteratura triestina del Novecento, affine a quelli proposti da Slataper, Carlo e Giani Stuparich e Manlio Cecovini. Allo stesso modo che l'affresco bellico emergente da La giovinezza di Ivo può far pensare ad Addio alle armi di Hemingway; e alludo, soprattutto, al finale del libro, ossia all'allontanamento dal fronte del protagonista Henry e al suo ritorno alla vita civile. E, anche, a Ritorno da Poggio Boschetto di Cecovini, nel quale c'è, del pari, un atteggiamento severamente critico nei confronti del regime fascista e della guerra.
Il romanzo di Di Giacomo è, oltre che triestino nel significato qui illustrato, "mitteleuropeo", per il rilievo che vi hanno il mondo slavo e, in specie, sloveno e il mondo asburgico, rievocato non senza nostalgia e rimpianto. Un romanzo onde affiora una Trieste non provinciale, non angustamente chiusa in se stessa, ma aperta all'Europa, umana, tollerante, consapevole della sua funzione storica, italiana e cosmopolita. Una Trieste non ripiegata inanemente sul suo pur illustre passato, ma protesa con fiducia verso un avvenire auspicabilmente migliore. Ivo è, si accennava, il centro del romanzo; ma sarebbe metodologicamente errato identificarlo tout court con l'autore.
 La giovinezza di Ivo, infatti, non è e non vuole
essere un'autobiografia; e non soltanto per l'uso, abbastanza indicativo, della
"terza persona", ma anche e soprattutto perché il protagonista,
quali che possano essere i suoi rapporti, comunque casuali e in ogni modo discreti,
con il medesimo Di Giacomo, è un'invenzione artistica, un personaggio
di fantasia. Da un simile punto di vista La giovinezza di Ivo è
qualcosa di molto diverso dal precedente romanzo Gli Jurcev ex A. U. Italia,
primo amore uscito nel 1973, che è una vasta, corale saga familiare,
ossia la storia della famiglia Jurcev, pendolare tra il mondo slavo e il mondo
italiano, dapprima sotto la dominazione austriaca e, dopo l'annessione di Trieste
all'Italia (1918), durante il ventennio fascista. In questa storia spicca il
protagonista Juri Jurcev (o Giorgio de Giorgi), negoziante al minuto, in cui
Di Giacomo ha adombrato la figura di suo padre. Dal canto suo, l'Ivo del secondo
romanzo è figlio di Juri; ma la relazione tra le due opere si ferma qui,
perché da una "cronaca familiare" si passa alla raffigurazione
autonoma e distaccata di un personaggio, Ivo, che ha poco o nulla da spartire
con l'autore ed è generalmente privo di apporti e agganci autobiografici.
La rappresentazione delle tre componenti tematiche della Giovinezza di Ivo
- la guerra, l'amore e l'introspezione - ha la sua migliore, più pertinente
espressione nel linguaggio del romanzo, caratterizzato da un costante desiderio
di concretezza, di verità o di verisimiglianza, e perciò gradevolmente
realistico; intessuto di frasi semplici e sobrie, limpide e lineari, puntualmente
denotative piuttosto che connotative, espositive e colloquiali piuttosto che
tese a impennate liriche, da "prosa d'arte". Tanto più che
nella Giovinezza di Ivo sono presenti (e ben riconoscibili) sia il gergo
studentesco, contrassegnato dall'uso compiaciuto e un po' ostentato e snobistico
del "latinorum", sia il gergo militare, ricco di parole e frasi
per lo più volgari, nei soldati e di copiosi riferimenti storici e politici
negli ufficiali. Mentre abbondano gli inserti dialettali e tedeschi, slavi,
croati, ecc., che accentuano il colore locale e riconfermano il significato
globale del romanzo, felice rievocazione e rappresentazione di un mondo di "confine"
o di "frontiera" - affine a quello presente nella narrativa di Tomizza
-, pluriculturale e plurilinguistico, emblematizzato nel personaggio di Ivo
e nelle sue vicende. Un mondo complesso e com-posito, che Nino Di Giacomo ha
esplorato in profondità e ha raffigurato con "intelletto d'amore"
nel suo romanzo.
La giovinezza di Ivo, infatti, non è e non vuole
essere un'autobiografia; e non soltanto per l'uso, abbastanza indicativo, della
"terza persona", ma anche e soprattutto perché il protagonista,
quali che possano essere i suoi rapporti, comunque casuali e in ogni modo discreti,
con il medesimo Di Giacomo, è un'invenzione artistica, un personaggio
di fantasia. Da un simile punto di vista La giovinezza di Ivo è
qualcosa di molto diverso dal precedente romanzo Gli Jurcev ex A. U. Italia,
primo amore uscito nel 1973, che è una vasta, corale saga familiare,
ossia la storia della famiglia Jurcev, pendolare tra il mondo slavo e il mondo
italiano, dapprima sotto la dominazione austriaca e, dopo l'annessione di Trieste
all'Italia (1918), durante il ventennio fascista. In questa storia spicca il
protagonista Juri Jurcev (o Giorgio de Giorgi), negoziante al minuto, in cui
Di Giacomo ha adombrato la figura di suo padre. Dal canto suo, l'Ivo del secondo
romanzo è figlio di Juri; ma la relazione tra le due opere si ferma qui,
perché da una "cronaca familiare" si passa alla raffigurazione
autonoma e distaccata di un personaggio, Ivo, che ha poco o nulla da spartire
con l'autore ed è generalmente privo di apporti e agganci autobiografici.
La rappresentazione delle tre componenti tematiche della Giovinezza di Ivo
- la guerra, l'amore e l'introspezione - ha la sua migliore, più pertinente
espressione nel linguaggio del romanzo, caratterizzato da un costante desiderio
di concretezza, di verità o di verisimiglianza, e perciò gradevolmente
realistico; intessuto di frasi semplici e sobrie, limpide e lineari, puntualmente
denotative piuttosto che connotative, espositive e colloquiali piuttosto che
tese a impennate liriche, da "prosa d'arte". Tanto più che
nella Giovinezza di Ivo sono presenti (e ben riconoscibili) sia il gergo
studentesco, contrassegnato dall'uso compiaciuto e un po' ostentato e snobistico
del "latinorum", sia il gergo militare, ricco di parole e frasi
per lo più volgari, nei soldati e di copiosi riferimenti storici e politici
negli ufficiali. Mentre abbondano gli inserti dialettali e tedeschi, slavi,
croati, ecc., che accentuano il colore locale e riconfermano il significato
globale del romanzo, felice rievocazione e rappresentazione di un mondo di "confine"
o di "frontiera" - affine a quello presente nella narrativa di Tomizza
-, pluriculturale e plurilinguistico, emblematizzato nel personaggio di Ivo
e nelle sue vicende. Un mondo complesso e com-posito, che Nino Di Giacomo ha
esplorato in profondità e ha raffigurato con "intelletto d'amore"
nel suo romanzo.
Bruno Maier
![]()
Nato a Trieste nel 1920 dal negoziante Antonio Jaklich (italianizzato in Di Giacomo) e da Maria Pia Lapagna, Nino (Antonio) Di Giacomo compì gli studi primari nella sua città. Frequentò quindi il liceo - ginnasio "Dante Alighieri", dove fu scolaro di Giani Stuparich. Nel 1943 si laureò in Scienze Politiche nell'Università di Firenze; e nel 1951 conseguì una seconda laurea in Giurisprudenza nell'Università di Milano. Successivamente esercitò per molti anni l'avvocatura. Fu uno dei fondatori del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste (1946), di cui è stato consigliere - segretario negli anni sociali 1946-1947, 1958-1959, 1959-1960 e 1960-1961. Morì a Trieste nel 1989. Pubblicò alcuni racconti in riviste e quotidiani locali del dopo guerra; e nel 1973 il romanzo Gli Jurcev ex A.U. Italia primo amore (Cittadella, Rebellato; e seconda edizione con introduzione di Bruno Maier, Trieste, Lint, 1977); cui segue ora, postumo, il romanzo La giovinezza di Ivo.
![]() ritorna
alla pagina generale della NARRATIVA
ritorna
alla pagina generale della NARRATIVA
![]()