|

|
PUBBLICAZIONI
SAGGISTICA
ADRIATICO IN FIAMME
«Tracce e memoria della Grande Guerra
negli scrittori giuliani »
MISCELLANEA DI STUDI
a cura di Fulvio Senardi
con i contributi di:
Cristina Benussi, Alberto Brambilla, Giovanni Capecchi, Stefano Carrai, Remo Castellini, Miran Košuta, Roberto Norbedo, Fulvio Senardi, Fabio Todero, Roberto Todero, Lorenzo Tommasini
pubblicato in aprile del 2019
ISBN 9-788894-427608
€ 15 - ordinabile qui
|
 |
 ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Cristina Benussi |
Alberto Brambilla |
Giovanni Capecchi |
Stefano Carrai |
Remo Castellini |
Miran Košuta |
Roberto Norbedo |
Roberto Todero |
Fabio Todero |
Lorenzo Tommasini |
Presentazione
Com’è ormai consolidata consuetudine l’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia porta alla stampa le relazioni del suo ultimo convegno: Adriatico in fiamme - Tracce e memoria della Grande Guerra negli scrittori giuliani (Trieste 30 novembre – 1 dicembre 2018). L’argomento dell’incontro, come si deduce dal titolo, risponde a una logica evidente: chiude, con una messa a fuoco locale ma, nell’auspicio degli organizzatori, non localistica, l’attività di ricerca e di promozione culturale organizzata dall’Istituto in relazione all’anniversario della Grande Guerra. Per quest’ultima scadenza l’Istituto giuliano si è avvalso della stretta collaborazione del Centro studi Scipio Slataper di Trieste, e ha potuto contare su un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui è stata tramite la Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, “capocordata” di un gruppo di associazioni che si sono mosse nell’ambito del progetto: “Adriatico inquieto 1918-1925” e di un contributo dell’Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. A tutti questi partner un sentito ringraziamento.
 Ciò che invece non risulta patente dal titolo scelto per il Convegno, e di cui ancora dovremo dire, è stato il tentativo di ricomporre, attraverso la diaristica, la narrativa e la poesia di guerra, quel particolare prisma cosmopolita di popolazioni e culture costituito, pur in una fase di crescente nazionalizzazione dei diversi gruppi etno-culturali, nei territori dell’Alto Adriatico sottoposti alla corona asburgica, ridando voce a scrittori di lingua e cultura diversa, ma tutti riconducibili all’area che dal punto di vista politico-amministrativo ha portato il nome, nell’ultima fase dell’Impero, di Österreichisches Küstenland (Avtrijsko Primorje in sloveno, Austrijsko Primorje in croato, Tengermellék in ungherese). Una regione che, su suggerimento di un illustre studioso (Graziadio Isaia Ascoli), gli italiani hanno chiamato Venezia Giulia, rivendicando le propria esclusiva autoctonia.
Ciò che invece non risulta patente dal titolo scelto per il Convegno, e di cui ancora dovremo dire, è stato il tentativo di ricomporre, attraverso la diaristica, la narrativa e la poesia di guerra, quel particolare prisma cosmopolita di popolazioni e culture costituito, pur in una fase di crescente nazionalizzazione dei diversi gruppi etno-culturali, nei territori dell’Alto Adriatico sottoposti alla corona asburgica, ridando voce a scrittori di lingua e cultura diversa, ma tutti riconducibili all’area che dal punto di vista politico-amministrativo ha portato il nome, nell’ultima fase dell’Impero, di Österreichisches Küstenland (Avtrijsko Primorje in sloveno, Austrijsko Primorje in croato, Tengermellék in ungherese). Una regione che, su suggerimento di un illustre studioso (Graziadio Isaia Ascoli), gli italiani hanno chiamato Venezia Giulia, rivendicando le propria esclusiva autoctonia.
La scelta di dar eco a quest’ultima espressione nel titolo del Convegno non cela però finalità nazionalistiche, né meno che meno sciovinistiche, ma è semplicemente funzionale alla diffusione del volume presso un pubblico di lingua italiana. Sappiamo fin troppo bene, e una bibliografia anche solo sommaria mostrerebbe la ricchezza di studi in proposito, quanto forti e crescenti fossero, al crepuscolo dell’Impero, gli antagonismi nazionali. Pronti a sfociare in aperta conflittualità dopo il disfacimento dello Stato asburgico. La Venezia Giulia, a questo riguardo, è esemplare: coloro che mal si tolleravano da cittadini di un medesimo Stato, infiammati nella contrapposizione delle rispettive rivendicazioni e murati nel reciproco sospetto, dopo il “ribalton” scoprono il nemico nel connazionale di un tempo (connazionale nel senso di appartenente ad uno stesso Stato, la “Doppelmonarchie”), protagonisti e insieme vittime del fenomeno della brutalizzazione della vita politica post-bellica, per dire con George Mosse.
Inizia, nelle aree periferiche dell’Impero dove era stata impossibile ogni integrazione delle nazionalità, una sorta di “guerra civile europea”, per adottare un’espressione di Ernst Nolte con una torsione di significato che certo lo storico, mancato nel 2016, non avrebbe accettato. Non il conflitto di bolscevismo e nazismo, ma quello fra gruppi nazionali che si fronteggiano per l’egemonia in territori dove sono presenti con ramificazioni secolari, e la cui assegnazione statuale, dopo il collasso imperiale, è destinata ovviamente ad aggravare le mutue incomprensioni. Un caos di dolorose e sanguinanti frizioni fra italiani e slavi, slavi e tedeschi dell’Austria (e, a fare un passettino più a Est, fra ungheresi e slavi e rumeni), ecc., le cui cicatrici, mantenute in modo più o meno strumentale in condizione di potenziale infiammazione, sono ancora oggi perfettamente visibili. È il “focolaio di crisi dell’Alto Adriatico”, come ha definito le nostre terre Rolf Wörsdörfer.
 Oggi guardiamo a quella stagione con rammarico, e non senza un filo di malinconia verso quei nonni così caparbi nei loro ideali di patria e di bandiera, interpretati in modo assoluto ed escludente, in molti casi fino al sacrificio della vita. Ma è cambiata la sensibilità e differenti sono gli ideali nei quali ci riconosciamo. «Trieste è un posto di transizione – geografica, storica, di cultura, di commercio – cioè di lotta. Ogni cosa è duplice o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e finendo con l’etnicità», constatava nel 1912 Scipio Slataper. Ma ciò che allora agli occhi di qualcuno poteva sembrare una condanna appare oggi a noi un invidiabile punto di partenza. Di cui non abbiamo ancora forse saputo pienamente approfittare. Ammoniscono gli scrittori, in questo caso Claudio Magris, che il «sentimento di appartenenza comune al composito mondo di confine» permette di ritrovare «nell’altro un elemento complementare e fondamentale della propria stessa identità». E Seamus Heaney, premio Nobel del 1995, poeta che porta sulla pagina l’esperienza degli anni passati a Belfast, «ci sono due modi in cui un luogo è conosciuto ed amato, due modi complementari ma anche antitetici: uno collegato al nostro vissuto, incolto e inconscio; l’altro, invece, colto, istruito e conscio». Ecco dunque: ci piace pensare (e non mancano i riscontri, penso a Slataper e a Kosovel, entrambi capaci di cogliere il valore dell’“altro” nel percorso quotidiano ed esistenziale tra il carso e il mare) che, sotto uno stesso cielo, di fronte ad uno stesso azzurro, mangiando gli stessi cibi, vivendo analoghi contesti professionali, vicini perfino nell’uso del tempo libero («Caffè di plebe [...] / [...] / E tu concili l’italo e lo slavo, / a tarda notte, lungo il tuo bigliardo») ecc., e di solito capaci di comunicare fra loro in una “lingua franca”, tedesco o italiano che fosse, le genti rivali dell’Österreichisches Küstenland esperissero inconsapevolmente una condizione di fratellanza, collegata al vissuto, incolta e inconscia», che ci è oggi più cara degli ideali che li separavano. Del resto l’universo di identità plurime ma sempre più integrate che ha rappresentato l’Impero asburgico nello svolgersi pluridecennale del suo crepuscolo aveva anche trovato una sponda politica intenzionata a garantire la pacifica evoluzione verso nuove forme istituzionali, e mi riferisco all’austro-marxismo, una matassa di sensibilità e dottrine capaci di rivoluzionare l’idea di nazione per rimodellarla in coerenza con la specificità asburgica. È un tema molto studiato e sarebbe velleitario volerlo riprendere nello spazio di qualche riga: resta il fatto che l’idea di “comunità di destino” (Schicksalgemeinschaft), inzialmente proposta da Otto Bauer, sembrava poter rovesciare nella prospettiva di un futuro pacificato un dato di natura apparentemente svantaggioso (al paragone con gli stati-nazione dello spazio europeo), ovvero la frammentazione etno-linguistica dell’ecumene imperiale. Idea generosa e non tanto utopica da non affascinare generazioni di intellettuali (anche nelle file dei posteri, se è vero che la riprende Edgar Morin nel libro del 1987, Penser l’Europe), e da non scontare, ai suoi tempi, la feroce opposizione dell’establishment (cultore, il ministro Taaffe lo aveva anche teorizzato, della dottrina del divide et impera). Poi, come spiegò Giani Stuparich, uno di coloro che avevano voluto scommettere su quel tanto osteggiato sole dell’avvenire, l’Austria dell’Impero volle imporsi sull’Austria dei popoli, e venne la guerra. Ma non sono i percorsi della teoria politica che intendiamo sondare. Ci interessava chiarire il punto di partenza da cui giungono fino a noi le voci del microsomo adriatico. “Assoggettate” al proprio ambiente, di cui in qualche caso pronunciano perfino le parole più intolleranti, ma insieme, e non sempre involontariamente, interlocutori delle nostre speranze di cittadini dell’Europa plurale.
Un profilo che riconosciamo nel ritratto collettivo che abbiamo avuto l’ambizione di proporre, di scrittori e di poeti scelti senza riguardo alla lingua, agli ideali o all’uniforme che indossarono da soldati, ma di condivisa radice nelle comunità alto-adriatiche, prese nel vortice della più terribile esperienza che una popolazione possa vivere, la guerra. Per individuare un altro legame che li affratella, e non solo tra loro ma con l’umanità tutta, «perché il dolore è eterno,/ ha una voce e non varia», come scrive il Poeta.
Oggi guardiamo a quella stagione con rammarico, e non senza un filo di malinconia verso quei nonni così caparbi nei loro ideali di patria e di bandiera, interpretati in modo assoluto ed escludente, in molti casi fino al sacrificio della vita. Ma è cambiata la sensibilità e differenti sono gli ideali nei quali ci riconosciamo. «Trieste è un posto di transizione – geografica, storica, di cultura, di commercio – cioè di lotta. Ogni cosa è duplice o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e finendo con l’etnicità», constatava nel 1912 Scipio Slataper. Ma ciò che allora agli occhi di qualcuno poteva sembrare una condanna appare oggi a noi un invidiabile punto di partenza. Di cui non abbiamo ancora forse saputo pienamente approfittare. Ammoniscono gli scrittori, in questo caso Claudio Magris, che il «sentimento di appartenenza comune al composito mondo di confine» permette di ritrovare «nell’altro un elemento complementare e fondamentale della propria stessa identità». E Seamus Heaney, premio Nobel del 1995, poeta che porta sulla pagina l’esperienza degli anni passati a Belfast, «ci sono due modi in cui un luogo è conosciuto ed amato, due modi complementari ma anche antitetici: uno collegato al nostro vissuto, incolto e inconscio; l’altro, invece, colto, istruito e conscio». Ecco dunque: ci piace pensare (e non mancano i riscontri, penso a Slataper e a Kosovel, entrambi capaci di cogliere il valore dell’“altro” nel percorso quotidiano ed esistenziale tra il carso e il mare) che, sotto uno stesso cielo, di fronte ad uno stesso azzurro, mangiando gli stessi cibi, vivendo analoghi contesti professionali, vicini perfino nell’uso del tempo libero («Caffè di plebe [...] / [...] / E tu concili l’italo e lo slavo, / a tarda notte, lungo il tuo bigliardo») ecc., e di solito capaci di comunicare fra loro in una “lingua franca”, tedesco o italiano che fosse, le genti rivali dell’Österreichisches Küstenland esperissero inconsapevolmente una condizione di fratellanza, collegata al vissuto, incolta e inconscia», che ci è oggi più cara degli ideali che li separavano. Del resto l’universo di identità plurime ma sempre più integrate che ha rappresentato l’Impero asburgico nello svolgersi pluridecennale del suo crepuscolo aveva anche trovato una sponda politica intenzionata a garantire la pacifica evoluzione verso nuove forme istituzionali, e mi riferisco all’austro-marxismo, una matassa di sensibilità e dottrine capaci di rivoluzionare l’idea di nazione per rimodellarla in coerenza con la specificità asburgica. È un tema molto studiato e sarebbe velleitario volerlo riprendere nello spazio di qualche riga: resta il fatto che l’idea di “comunità di destino” (Schicksalgemeinschaft), inzialmente proposta da Otto Bauer, sembrava poter rovesciare nella prospettiva di un futuro pacificato un dato di natura apparentemente svantaggioso (al paragone con gli stati-nazione dello spazio europeo), ovvero la frammentazione etno-linguistica dell’ecumene imperiale. Idea generosa e non tanto utopica da non affascinare generazioni di intellettuali (anche nelle file dei posteri, se è vero che la riprende Edgar Morin nel libro del 1987, Penser l’Europe), e da non scontare, ai suoi tempi, la feroce opposizione dell’establishment (cultore, il ministro Taaffe lo aveva anche teorizzato, della dottrina del divide et impera). Poi, come spiegò Giani Stuparich, uno di coloro che avevano voluto scommettere su quel tanto osteggiato sole dell’avvenire, l’Austria dell’Impero volle imporsi sull’Austria dei popoli, e venne la guerra. Ma non sono i percorsi della teoria politica che intendiamo sondare. Ci interessava chiarire il punto di partenza da cui giungono fino a noi le voci del microsomo adriatico. “Assoggettate” al proprio ambiente, di cui in qualche caso pronunciano perfino le parole più intolleranti, ma insieme, e non sempre involontariamente, interlocutori delle nostre speranze di cittadini dell’Europa plurale.
Un profilo che riconosciamo nel ritratto collettivo che abbiamo avuto l’ambizione di proporre, di scrittori e di poeti scelti senza riguardo alla lingua, agli ideali o all’uniforme che indossarono da soldati, ma di condivisa radice nelle comunità alto-adriatiche, prese nel vortice della più terribile esperienza che una popolazione possa vivere, la guerra. Per individuare un altro legame che li affratella, e non solo tra loro ma con l’umanità tutta, «perché il dolore è eterno,/ ha una voce e non varia», come scrive il Poeta.
Per più aspetti le celebrazioni della Grande Guerra sono state, non nascondiamocelo, una delusione. Vecchie parole d’ordine riaffioranti nei “fervorini” dell’anniversario hanno reso quasi impossibile affrontare l’evento, sul piano pubblico, con quella ricchezza di problematicità e vivacità di aperture critiche necessarie da una lato, a una piena comprensione dell’evento, dall’altro utili ad una vera crescita civile. Tutto soffocato da bandiere e fanfare. O dal generico ciccaleccio dei “gazzettieri” pronti ad ogni tema con la loro penna disinvolta, promotori – cedo la parola a Quinto Antonelli (l’autore di Cento anni di Grande Guerra, ciò che di meglio è stato scritto per filtrare il torbido dell’alluvione celebrativa) – di «operazioni giornalistiche, anche quelle compiute con le migliori intenzioni, tutte al di qua della storia: siano esse sintesi biografiche, riscritture più o meno estetizzanti, generose citazioni o antologie cronologiche, tutte si sottraggono a una pur minima critica delle fonti e a una pur semplice contestualizzazione storica».
 Peggio nelle sedi ufficiali di più grande visibilità e prestigio. Ha dato la misura della corsa sul posto il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Salvatore Farina, affermando, in una intervista pubblicata sul «Corriere della Sera», che la Grande Guerra è stato «l’ultimo atto del Risorgimento [...] sacrificio necessario per l’unità nazionale». Se apriamo uno dei libri di cui si discute nelle pagine che seguono, possiamo leggere: «era commosso il buon colonnello. [...] Parlava alla buona [...] ricordava le guerre d’indipendenza, diceva che bisognava completare l’unità della patria» (Federico Pagnacco, La storia di Fabio). Le stellette appaiono dunque assolutamente fedeli a una visione semplificata e convenzionale (e dire che la Storia è per eccellenza un campo problematico di sistemi complessi...). Peraltro, è evidente che nei saggi che presentiamo, concentrati su specifiche figure di scrittori e quindi attenti al dato biografico e all’esperienza letteraria, ci sarà poco spazio per raddrizzare il tiro, costruendo un percorso analitico, problematizzante, attento alla complessità e sensibile a fattori multicausali. Quel fervore di idee, spunti, linee di ricerche – il rovescio della medaglia delle celebrazioni ufficiali – che, nonostante tutto, ha portato a nuovi acquisti storiografici, nella scoperta di fonti inedite, nella proposta di nuovi approcci, nell’interesse per temi un tempo poco frequentati (la storia di genere, della psicologia collettiva, delle occupazioni e delle esulanze, ecc.) resta sullo sfondo, come un dato lontano, perché ciò che ci ha interessato è la singolarità dell’esperienza di scrittura. Per altro, a voler leggere senza i paraocchi imposti dalle celebrazioni, della Grande Guerra si sa ormai tutto o quasi, grazie a più generazioni di storici veri: le insufficienze delle élite e le motivazioni meno confessabili che spinsero a mettere a fuoco un continente; la gestione della guerra nel totale disprezzo, per gran parte di essa, delle esigenze della truppa, vera carne da cannone (meglio se socialista: e qui l’implicità finalità conservatrice); la compressione spietata del fronte interno, con misure che, in Italia (tribunali militari per i civili accusati di disfattismo) e in Austria (scioglimento del Parlamento e “regime” militare) furono fra le più dure d’Europa e fecero il paio con la severità della giustizia militare, la più inflessibile sotto il tricolore tra quelle dei Paesi di cui abbiamo documentazione. Molti storici hanno spiegato, illustrato, ribadito (penso al lavoro straordinario fatto da Giovanna Procacci, Bruna Bianchi, Nicola Labanca per dire solo qualche nome), senza cedere alle sirene dell’entusiasmo che, alle scadenze degli anniversari, possono facilmente travolgere (il “non dobbiamo vergognarci di aver vinto” proferito di recente da un nome illustre della disciplina). Vergognarci no, ma conta anche il come.
Peggio nelle sedi ufficiali di più grande visibilità e prestigio. Ha dato la misura della corsa sul posto il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Salvatore Farina, affermando, in una intervista pubblicata sul «Corriere della Sera», che la Grande Guerra è stato «l’ultimo atto del Risorgimento [...] sacrificio necessario per l’unità nazionale». Se apriamo uno dei libri di cui si discute nelle pagine che seguono, possiamo leggere: «era commosso il buon colonnello. [...] Parlava alla buona [...] ricordava le guerre d’indipendenza, diceva che bisognava completare l’unità della patria» (Federico Pagnacco, La storia di Fabio). Le stellette appaiono dunque assolutamente fedeli a una visione semplificata e convenzionale (e dire che la Storia è per eccellenza un campo problematico di sistemi complessi...). Peraltro, è evidente che nei saggi che presentiamo, concentrati su specifiche figure di scrittori e quindi attenti al dato biografico e all’esperienza letteraria, ci sarà poco spazio per raddrizzare il tiro, costruendo un percorso analitico, problematizzante, attento alla complessità e sensibile a fattori multicausali. Quel fervore di idee, spunti, linee di ricerche – il rovescio della medaglia delle celebrazioni ufficiali – che, nonostante tutto, ha portato a nuovi acquisti storiografici, nella scoperta di fonti inedite, nella proposta di nuovi approcci, nell’interesse per temi un tempo poco frequentati (la storia di genere, della psicologia collettiva, delle occupazioni e delle esulanze, ecc.) resta sullo sfondo, come un dato lontano, perché ciò che ci ha interessato è la singolarità dell’esperienza di scrittura. Per altro, a voler leggere senza i paraocchi imposti dalle celebrazioni, della Grande Guerra si sa ormai tutto o quasi, grazie a più generazioni di storici veri: le insufficienze delle élite e le motivazioni meno confessabili che spinsero a mettere a fuoco un continente; la gestione della guerra nel totale disprezzo, per gran parte di essa, delle esigenze della truppa, vera carne da cannone (meglio se socialista: e qui l’implicità finalità conservatrice); la compressione spietata del fronte interno, con misure che, in Italia (tribunali militari per i civili accusati di disfattismo) e in Austria (scioglimento del Parlamento e “regime” militare) furono fra le più dure d’Europa e fecero il paio con la severità della giustizia militare, la più inflessibile sotto il tricolore tra quelle dei Paesi di cui abbiamo documentazione. Molti storici hanno spiegato, illustrato, ribadito (penso al lavoro straordinario fatto da Giovanna Procacci, Bruna Bianchi, Nicola Labanca per dire solo qualche nome), senza cedere alle sirene dell’entusiasmo che, alle scadenze degli anniversari, possono facilmente travolgere (il “non dobbiamo vergognarci di aver vinto” proferito di recente da un nome illustre della disciplina). Vergognarci no, ma conta anche il come.
Ed è a questi studiosi dunque, e ai giovani storici che ne hanno seguito le tracce, che rimandiamo per gli approfondimenti impossibili nel nostro libro, dove aspetti anche cruciali ma di carattere generale o periferici al problema letterario vengono solo allusi e quindi rimangono, nella sostanza, inevasi. Nessuno ci venga a dire, però, che non sapeva, intonando la litania di cui si è fatto spreco a proposito delle foibe, non certo un tema storiografico che nasce ieri l’altro, come sostiene per proprio tornaconto una certa parte politica, e con essa i profughi di professione, saldamente organizzati in gruppi di pressione a caccia di sovvenzioni pubbliche.
 Scorrendo le pagine di questo libro, bisogna però ancora constatare che, com’era da aspettarsi, il drappello degli scrittori giuliani che, dopo aver vestito il grigio-verde, scrivono in italiano è fittamente rappresentato a spese delle altre lingue e delle altre divise. Un dato logico e scontato in un incontro soprattutto di italianisti. Non tanto ovvio forse il fatto che nessuno scrittore sia stato chiamato a farsi interprete della schiera degli oltre cinquantamila giuliani italofoni che difesero i colori imperiali in Galizia e sull’Isonzo, sul mare e come soldati della riserva. Il tema non è certo inedito, se ne sono occupati Lawrence Sondhaus (con un saggio che continua ad essere, per il periodo che precede la Grande Guerra, opera di riferimento: In the Service of the Emperor - Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918, 1990), Andrea Di Michele (Fra due divise - La Grande Guerra degli italiani d’Austria, 2018) e, con particolare attenzione al caso giuliano, Roberto Todero (Dalla Galizia all’Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella Grande Guerra, 2006). Mentre, da parte sua, Marina Rossi, non ha cessato di scavare negli archivi per una migliore comprensione di ciò che è accaduto sul fronte orientale, seguendo il labirintico dipanarsi dei destini (I prigionieri dello zar, 2011). Il fatto è però che, se è vero che la storia la fanno i vincitori, i giuliani di lingua italiana che servirono sotto la bandiera asburgica scelsero, al ritorno a casa, il silenzio (a differenza dei trentini, dove il patrimonio di diari e memorie della guerra per il Kaiser è potuto fluire con più libero corso e da cui ci si può ancora attendere qualche ampliamento d’orizzonte). La loro causa, sia stata difesa con entusiasmo, per intima adesione, per ossequio alle leggi dello Stato oppure semplicemente con la rassegnazione dei sudditi, ne usciva totalmente sconfitta. Amarezza, umiliazione, e forse, un sospetto di tradimento, accompagnavano il reinserimento dei reduci nella Trieste italiana. Per attenuare il contrasto tra fedeltà all’Impero e nuova appartenenza statuale delle terre d’origine nasce così la leggenda dei “demoghèla” o “pomigadori”. Quei negligenti, lavativi, disfattisti per convinzione, per farla breve i perfetti Sc’veik adriatici che sarebbero stati i soldati italofoni sotto bandiera austriaca, spina nel fianco dell’esercito di cui vestivano la divisa e quindi oggettivamente quinte colonne dell’Intesa (una leggenda smentita da tutti gli storici militari). Per altro, tacendo sugli anni in feldgrau, sbarazzatisi di mostrine, decorazioni e divisa, riponendo negli angoli di qualche cassetto le lettere che davano testimonianza della loro guerra (merito di Roberto Todero aver reso noto un carteggio particolarmente nutrito), avrebbero dovuto rassegnarsi a riconoscere la propria storia nelle pagine di chi, con ricca pietas e sicuro della propria scelta “giusta”, avesse voluto interessarsi al loro destino dimenticato. Un Giani Stuparich, per esempio, medaglia d’oro dell’Esercito italiano come il fratello Carlo, che dedica qualche capitolo di Ritorneranno alla vicenda di Domenico (in cui lo scrittore proietta molti tratti della figura paterna), soldato dell’esercito austriaco con tre figli, i protagonisti del romanzo, volontari in quello italiano: un uomo che ritorna a casa, racconta Stuparich, con “i segni di un crollo interiore”. Un unicum il volume di memorie di Antonio Budinich di Lussino (Budini dal 1937), stilato nel decennio 1939-49 e pubblicato nel 2013. Se sono forse ragioni di opportunità a suggerire gli incisi in cui l’estensore, ufficiale dell’esercito asburgico, dichiara la sua simpatia per la causa dell’Intesa (come pure ad avergli fatto “scordare”, come nota Adriano Andri, Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale, la decorazione ricevuta nel corso del conflitto), il diario è probabilmente il solo testo sulla guerra degli austro-italiani della Giulia in divisa austriaca che ci sia giunto completo, tracciando una parabola che inizia e finisce tra il ’14 e il ‘18, e non in forma di scaglie di memoria, incisi, allusioni, lettere – o brandelli di esse – rubati al macero e alla dimenticanza.
Scorrendo le pagine di questo libro, bisogna però ancora constatare che, com’era da aspettarsi, il drappello degli scrittori giuliani che, dopo aver vestito il grigio-verde, scrivono in italiano è fittamente rappresentato a spese delle altre lingue e delle altre divise. Un dato logico e scontato in un incontro soprattutto di italianisti. Non tanto ovvio forse il fatto che nessuno scrittore sia stato chiamato a farsi interprete della schiera degli oltre cinquantamila giuliani italofoni che difesero i colori imperiali in Galizia e sull’Isonzo, sul mare e come soldati della riserva. Il tema non è certo inedito, se ne sono occupati Lawrence Sondhaus (con un saggio che continua ad essere, per il periodo che precede la Grande Guerra, opera di riferimento: In the Service of the Emperor - Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918, 1990), Andrea Di Michele (Fra due divise - La Grande Guerra degli italiani d’Austria, 2018) e, con particolare attenzione al caso giuliano, Roberto Todero (Dalla Galizia all’Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella Grande Guerra, 2006). Mentre, da parte sua, Marina Rossi, non ha cessato di scavare negli archivi per una migliore comprensione di ciò che è accaduto sul fronte orientale, seguendo il labirintico dipanarsi dei destini (I prigionieri dello zar, 2011). Il fatto è però che, se è vero che la storia la fanno i vincitori, i giuliani di lingua italiana che servirono sotto la bandiera asburgica scelsero, al ritorno a casa, il silenzio (a differenza dei trentini, dove il patrimonio di diari e memorie della guerra per il Kaiser è potuto fluire con più libero corso e da cui ci si può ancora attendere qualche ampliamento d’orizzonte). La loro causa, sia stata difesa con entusiasmo, per intima adesione, per ossequio alle leggi dello Stato oppure semplicemente con la rassegnazione dei sudditi, ne usciva totalmente sconfitta. Amarezza, umiliazione, e forse, un sospetto di tradimento, accompagnavano il reinserimento dei reduci nella Trieste italiana. Per attenuare il contrasto tra fedeltà all’Impero e nuova appartenenza statuale delle terre d’origine nasce così la leggenda dei “demoghèla” o “pomigadori”. Quei negligenti, lavativi, disfattisti per convinzione, per farla breve i perfetti Sc’veik adriatici che sarebbero stati i soldati italofoni sotto bandiera austriaca, spina nel fianco dell’esercito di cui vestivano la divisa e quindi oggettivamente quinte colonne dell’Intesa (una leggenda smentita da tutti gli storici militari). Per altro, tacendo sugli anni in feldgrau, sbarazzatisi di mostrine, decorazioni e divisa, riponendo negli angoli di qualche cassetto le lettere che davano testimonianza della loro guerra (merito di Roberto Todero aver reso noto un carteggio particolarmente nutrito), avrebbero dovuto rassegnarsi a riconoscere la propria storia nelle pagine di chi, con ricca pietas e sicuro della propria scelta “giusta”, avesse voluto interessarsi al loro destino dimenticato. Un Giani Stuparich, per esempio, medaglia d’oro dell’Esercito italiano come il fratello Carlo, che dedica qualche capitolo di Ritorneranno alla vicenda di Domenico (in cui lo scrittore proietta molti tratti della figura paterna), soldato dell’esercito austriaco con tre figli, i protagonisti del romanzo, volontari in quello italiano: un uomo che ritorna a casa, racconta Stuparich, con “i segni di un crollo interiore”. Un unicum il volume di memorie di Antonio Budinich di Lussino (Budini dal 1937), stilato nel decennio 1939-49 e pubblicato nel 2013. Se sono forse ragioni di opportunità a suggerire gli incisi in cui l’estensore, ufficiale dell’esercito asburgico, dichiara la sua simpatia per la causa dell’Intesa (come pure ad avergli fatto “scordare”, come nota Adriano Andri, Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale, la decorazione ricevuta nel corso del conflitto), il diario è probabilmente il solo testo sulla guerra degli austro-italiani della Giulia in divisa austriaca che ci sia giunto completo, tracciando una parabola che inizia e finisce tra il ’14 e il ‘18, e non in forma di scaglie di memoria, incisi, allusioni, lettere – o brandelli di esse – rubati al macero e alla dimenticanza.
Detto questo lascio la parola ai saggi che seguono. Tutti ordinati alfabeticamente secondo il nome dell’autore, salvo il primo, al Convegno e nel libro, in cui Cristina Benussi, docente all’Ateneo di Trieste, ha inquadrato il discorso in una prospettiva più ampia di storia e di cultura.
Fulvio Senardi
Presidente dell’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione
 |
 |
Articolo a firma di Pietro Spirito pubblicato sul Piccolo di Trieste il 28 maggio 2019
Clicca sull'articolo per ingrandire e leggere
|
 |
Articolo a firma del prof. Fulvio Salimbeni pubblicato su PANORAMA di maggio 2019
Clicca sull'articolo per ingrandire e leggere |
|
 |
 |
 |
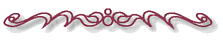
- documento pubblicato in Aprile 2019 -
 ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA
ritorna alla pagina generale della SAGGISTICA

![]()











 Ciò che invece non risulta patente dal titolo scelto per il Convegno, e di cui ancora dovremo dire, è stato il tentativo di ricomporre, attraverso la diaristica, la narrativa e la poesia di guerra, quel particolare prisma cosmopolita di popolazioni e culture costituito, pur in una fase di crescente nazionalizzazione dei diversi gruppi etno-culturali, nei territori dell’Alto Adriatico sottoposti alla corona asburgica, ridando voce a scrittori di lingua e cultura diversa, ma tutti riconducibili all’area che dal punto di vista politico-amministrativo ha portato il nome, nell’ultima fase dell’Impero, di Österreichisches Küstenland (Avtrijsko Primorje in sloveno, Austrijsko Primorje in croato, Tengermellék in ungherese). Una regione che, su suggerimento di un illustre studioso (Graziadio Isaia Ascoli), gli italiani hanno chiamato Venezia Giulia, rivendicando le propria esclusiva autoctonia.
Ciò che invece non risulta patente dal titolo scelto per il Convegno, e di cui ancora dovremo dire, è stato il tentativo di ricomporre, attraverso la diaristica, la narrativa e la poesia di guerra, quel particolare prisma cosmopolita di popolazioni e culture costituito, pur in una fase di crescente nazionalizzazione dei diversi gruppi etno-culturali, nei territori dell’Alto Adriatico sottoposti alla corona asburgica, ridando voce a scrittori di lingua e cultura diversa, ma tutti riconducibili all’area che dal punto di vista politico-amministrativo ha portato il nome, nell’ultima fase dell’Impero, di Österreichisches Küstenland (Avtrijsko Primorje in sloveno, Austrijsko Primorje in croato, Tengermellék in ungherese). Una regione che, su suggerimento di un illustre studioso (Graziadio Isaia Ascoli), gli italiani hanno chiamato Venezia Giulia, rivendicando le propria esclusiva autoctonia. Oggi guardiamo a quella stagione con rammarico, e non senza un filo di malinconia verso quei nonni così caparbi nei loro ideali di patria e di bandiera, interpretati in modo assoluto ed escludente, in molti casi fino al sacrificio della vita. Ma è cambiata la sensibilità e differenti sono gli ideali nei quali ci riconosciamo. «Trieste è un posto di transizione – geografica, storica, di cultura, di commercio – cioè di lotta. Ogni cosa è duplice o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e finendo con l’etnicità», constatava nel 1912 Scipio Slataper. Ma ciò che allora agli occhi di qualcuno poteva sembrare una condanna appare oggi a noi un invidiabile punto di partenza. Di cui non abbiamo ancora forse saputo pienamente approfittare. Ammoniscono gli scrittori, in questo caso Claudio Magris, che il «sentimento di appartenenza comune al composito mondo di confine» permette di ritrovare «nell’altro un elemento complementare e fondamentale della propria stessa identità». E Seamus Heaney, premio Nobel del 1995, poeta che porta sulla pagina l’esperienza degli anni passati a Belfast, «ci sono due modi in cui un luogo è conosciuto ed amato, due modi complementari ma anche antitetici: uno collegato al nostro vissuto, incolto e inconscio; l’altro, invece, colto, istruito e conscio». Ecco dunque: ci piace pensare (e non mancano i riscontri, penso a Slataper e a Kosovel, entrambi capaci di cogliere il valore dell’“altro” nel percorso quotidiano ed esistenziale tra il carso e il mare) che, sotto uno stesso cielo, di fronte ad uno stesso azzurro, mangiando gli stessi cibi, vivendo analoghi contesti professionali, vicini perfino nell’uso del tempo libero («Caffè di plebe [...] / [...] / E tu concili l’italo e lo slavo, / a tarda notte, lungo il tuo bigliardo») ecc., e di solito capaci di comunicare fra loro in una “lingua franca”, tedesco o italiano che fosse, le genti rivali dell’Österreichisches Küstenland esperissero inconsapevolmente una condizione di fratellanza, collegata al vissuto, incolta e inconscia», che ci è oggi più cara degli ideali che li separavano. Del resto l’universo di identità plurime ma sempre più integrate che ha rappresentato l’Impero asburgico nello svolgersi pluridecennale del suo crepuscolo aveva anche trovato una sponda politica intenzionata a garantire la pacifica evoluzione verso nuove forme istituzionali, e mi riferisco all’austro-marxismo, una matassa di sensibilità e dottrine capaci di rivoluzionare l’idea di nazione per rimodellarla in coerenza con la specificità asburgica. È un tema molto studiato e sarebbe velleitario volerlo riprendere nello spazio di qualche riga: resta il fatto che l’idea di “comunità di destino” (Schicksalgemeinschaft), inzialmente proposta da Otto Bauer, sembrava poter rovesciare nella prospettiva di un futuro pacificato un dato di natura apparentemente svantaggioso (al paragone con gli stati-nazione dello spazio europeo), ovvero la frammentazione etno-linguistica dell’ecumene imperiale. Idea generosa e non tanto utopica da non affascinare generazioni di intellettuali (anche nelle file dei posteri, se è vero che la riprende Edgar Morin nel libro del 1987, Penser l’Europe), e da non scontare, ai suoi tempi, la feroce opposizione dell’establishment (cultore, il ministro Taaffe lo aveva anche teorizzato, della dottrina del divide et impera). Poi, come spiegò Giani Stuparich, uno di coloro che avevano voluto scommettere su quel tanto osteggiato sole dell’avvenire, l’Austria dell’Impero volle imporsi sull’Austria dei popoli, e venne la guerra. Ma non sono i percorsi della teoria politica che intendiamo sondare. Ci interessava chiarire il punto di partenza da cui giungono fino a noi le voci del microsomo adriatico. “Assoggettate” al proprio ambiente, di cui in qualche caso pronunciano perfino le parole più intolleranti, ma insieme, e non sempre involontariamente, interlocutori delle nostre speranze di cittadini dell’Europa plurale.
Un profilo che riconosciamo nel ritratto collettivo che abbiamo avuto l’ambizione di proporre, di scrittori e di poeti scelti senza riguardo alla lingua, agli ideali o all’uniforme che indossarono da soldati, ma di condivisa radice nelle comunità alto-adriatiche, prese nel vortice della più terribile esperienza che una popolazione possa vivere, la guerra. Per individuare un altro legame che li affratella, e non solo tra loro ma con l’umanità tutta, «perché il dolore è eterno,/ ha una voce e non varia», come scrive il Poeta.
Oggi guardiamo a quella stagione con rammarico, e non senza un filo di malinconia verso quei nonni così caparbi nei loro ideali di patria e di bandiera, interpretati in modo assoluto ed escludente, in molti casi fino al sacrificio della vita. Ma è cambiata la sensibilità e differenti sono gli ideali nei quali ci riconosciamo. «Trieste è un posto di transizione – geografica, storica, di cultura, di commercio – cioè di lotta. Ogni cosa è duplice o triplice a Trieste, cominciando dalla flora e finendo con l’etnicità», constatava nel 1912 Scipio Slataper. Ma ciò che allora agli occhi di qualcuno poteva sembrare una condanna appare oggi a noi un invidiabile punto di partenza. Di cui non abbiamo ancora forse saputo pienamente approfittare. Ammoniscono gli scrittori, in questo caso Claudio Magris, che il «sentimento di appartenenza comune al composito mondo di confine» permette di ritrovare «nell’altro un elemento complementare e fondamentale della propria stessa identità». E Seamus Heaney, premio Nobel del 1995, poeta che porta sulla pagina l’esperienza degli anni passati a Belfast, «ci sono due modi in cui un luogo è conosciuto ed amato, due modi complementari ma anche antitetici: uno collegato al nostro vissuto, incolto e inconscio; l’altro, invece, colto, istruito e conscio». Ecco dunque: ci piace pensare (e non mancano i riscontri, penso a Slataper e a Kosovel, entrambi capaci di cogliere il valore dell’“altro” nel percorso quotidiano ed esistenziale tra il carso e il mare) che, sotto uno stesso cielo, di fronte ad uno stesso azzurro, mangiando gli stessi cibi, vivendo analoghi contesti professionali, vicini perfino nell’uso del tempo libero («Caffè di plebe [...] / [...] / E tu concili l’italo e lo slavo, / a tarda notte, lungo il tuo bigliardo») ecc., e di solito capaci di comunicare fra loro in una “lingua franca”, tedesco o italiano che fosse, le genti rivali dell’Österreichisches Küstenland esperissero inconsapevolmente una condizione di fratellanza, collegata al vissuto, incolta e inconscia», che ci è oggi più cara degli ideali che li separavano. Del resto l’universo di identità plurime ma sempre più integrate che ha rappresentato l’Impero asburgico nello svolgersi pluridecennale del suo crepuscolo aveva anche trovato una sponda politica intenzionata a garantire la pacifica evoluzione verso nuove forme istituzionali, e mi riferisco all’austro-marxismo, una matassa di sensibilità e dottrine capaci di rivoluzionare l’idea di nazione per rimodellarla in coerenza con la specificità asburgica. È un tema molto studiato e sarebbe velleitario volerlo riprendere nello spazio di qualche riga: resta il fatto che l’idea di “comunità di destino” (Schicksalgemeinschaft), inzialmente proposta da Otto Bauer, sembrava poter rovesciare nella prospettiva di un futuro pacificato un dato di natura apparentemente svantaggioso (al paragone con gli stati-nazione dello spazio europeo), ovvero la frammentazione etno-linguistica dell’ecumene imperiale. Idea generosa e non tanto utopica da non affascinare generazioni di intellettuali (anche nelle file dei posteri, se è vero che la riprende Edgar Morin nel libro del 1987, Penser l’Europe), e da non scontare, ai suoi tempi, la feroce opposizione dell’establishment (cultore, il ministro Taaffe lo aveva anche teorizzato, della dottrina del divide et impera). Poi, come spiegò Giani Stuparich, uno di coloro che avevano voluto scommettere su quel tanto osteggiato sole dell’avvenire, l’Austria dell’Impero volle imporsi sull’Austria dei popoli, e venne la guerra. Ma non sono i percorsi della teoria politica che intendiamo sondare. Ci interessava chiarire il punto di partenza da cui giungono fino a noi le voci del microsomo adriatico. “Assoggettate” al proprio ambiente, di cui in qualche caso pronunciano perfino le parole più intolleranti, ma insieme, e non sempre involontariamente, interlocutori delle nostre speranze di cittadini dell’Europa plurale.
Un profilo che riconosciamo nel ritratto collettivo che abbiamo avuto l’ambizione di proporre, di scrittori e di poeti scelti senza riguardo alla lingua, agli ideali o all’uniforme che indossarono da soldati, ma di condivisa radice nelle comunità alto-adriatiche, prese nel vortice della più terribile esperienza che una popolazione possa vivere, la guerra. Per individuare un altro legame che li affratella, e non solo tra loro ma con l’umanità tutta, «perché il dolore è eterno,/ ha una voce e non varia», come scrive il Poeta. Peggio nelle sedi ufficiali di più grande visibilità e prestigio. Ha dato la misura della corsa sul posto il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Salvatore Farina, affermando, in una intervista pubblicata sul «Corriere della Sera», che la Grande Guerra è stato «l’ultimo atto del Risorgimento [...] sacrificio necessario per l’unità nazionale». Se apriamo uno dei libri di cui si discute nelle pagine che seguono, possiamo leggere: «era commosso il buon colonnello. [...] Parlava alla buona [...] ricordava le guerre d’indipendenza, diceva che bisognava completare l’unità della patria» (Federico Pagnacco, La storia di Fabio). Le stellette appaiono dunque assolutamente fedeli a una visione semplificata e convenzionale (e dire che la Storia è per eccellenza un campo problematico di sistemi complessi...). Peraltro, è evidente che nei saggi che presentiamo, concentrati su specifiche figure di scrittori e quindi attenti al dato biografico e all’esperienza letteraria, ci sarà poco spazio per raddrizzare il tiro, costruendo un percorso analitico, problematizzante, attento alla complessità e sensibile a fattori multicausali. Quel fervore di idee, spunti, linee di ricerche – il rovescio della medaglia delle celebrazioni ufficiali – che, nonostante tutto, ha portato a nuovi acquisti storiografici, nella scoperta di fonti inedite, nella proposta di nuovi approcci, nell’interesse per temi un tempo poco frequentati (la storia di genere, della psicologia collettiva, delle occupazioni e delle esulanze, ecc.) resta sullo sfondo, come un dato lontano, perché ciò che ci ha interessato è la singolarità dell’esperienza di scrittura. Per altro, a voler leggere senza i paraocchi imposti dalle celebrazioni, della Grande Guerra si sa ormai tutto o quasi, grazie a più generazioni di storici veri: le insufficienze delle élite e le motivazioni meno confessabili che spinsero a mettere a fuoco un continente; la gestione della guerra nel totale disprezzo, per gran parte di essa, delle esigenze della truppa, vera carne da cannone (meglio se socialista: e qui l’implicità finalità conservatrice); la compressione spietata del fronte interno, con misure che, in Italia (tribunali militari per i civili accusati di disfattismo) e in Austria (scioglimento del Parlamento e “regime” militare) furono fra le più dure d’Europa e fecero il paio con la severità della giustizia militare, la più inflessibile sotto il tricolore tra quelle dei Paesi di cui abbiamo documentazione. Molti storici hanno spiegato, illustrato, ribadito (penso al lavoro straordinario fatto da Giovanna Procacci, Bruna Bianchi, Nicola Labanca per dire solo qualche nome), senza cedere alle sirene dell’entusiasmo che, alle scadenze degli anniversari, possono facilmente travolgere (il “non dobbiamo vergognarci di aver vinto” proferito di recente da un nome illustre della disciplina). Vergognarci no, ma conta anche il come.
Peggio nelle sedi ufficiali di più grande visibilità e prestigio. Ha dato la misura della corsa sul posto il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Salvatore Farina, affermando, in una intervista pubblicata sul «Corriere della Sera», che la Grande Guerra è stato «l’ultimo atto del Risorgimento [...] sacrificio necessario per l’unità nazionale». Se apriamo uno dei libri di cui si discute nelle pagine che seguono, possiamo leggere: «era commosso il buon colonnello. [...] Parlava alla buona [...] ricordava le guerre d’indipendenza, diceva che bisognava completare l’unità della patria» (Federico Pagnacco, La storia di Fabio). Le stellette appaiono dunque assolutamente fedeli a una visione semplificata e convenzionale (e dire che la Storia è per eccellenza un campo problematico di sistemi complessi...). Peraltro, è evidente che nei saggi che presentiamo, concentrati su specifiche figure di scrittori e quindi attenti al dato biografico e all’esperienza letteraria, ci sarà poco spazio per raddrizzare il tiro, costruendo un percorso analitico, problematizzante, attento alla complessità e sensibile a fattori multicausali. Quel fervore di idee, spunti, linee di ricerche – il rovescio della medaglia delle celebrazioni ufficiali – che, nonostante tutto, ha portato a nuovi acquisti storiografici, nella scoperta di fonti inedite, nella proposta di nuovi approcci, nell’interesse per temi un tempo poco frequentati (la storia di genere, della psicologia collettiva, delle occupazioni e delle esulanze, ecc.) resta sullo sfondo, come un dato lontano, perché ciò che ci ha interessato è la singolarità dell’esperienza di scrittura. Per altro, a voler leggere senza i paraocchi imposti dalle celebrazioni, della Grande Guerra si sa ormai tutto o quasi, grazie a più generazioni di storici veri: le insufficienze delle élite e le motivazioni meno confessabili che spinsero a mettere a fuoco un continente; la gestione della guerra nel totale disprezzo, per gran parte di essa, delle esigenze della truppa, vera carne da cannone (meglio se socialista: e qui l’implicità finalità conservatrice); la compressione spietata del fronte interno, con misure che, in Italia (tribunali militari per i civili accusati di disfattismo) e in Austria (scioglimento del Parlamento e “regime” militare) furono fra le più dure d’Europa e fecero il paio con la severità della giustizia militare, la più inflessibile sotto il tricolore tra quelle dei Paesi di cui abbiamo documentazione. Molti storici hanno spiegato, illustrato, ribadito (penso al lavoro straordinario fatto da Giovanna Procacci, Bruna Bianchi, Nicola Labanca per dire solo qualche nome), senza cedere alle sirene dell’entusiasmo che, alle scadenze degli anniversari, possono facilmente travolgere (il “non dobbiamo vergognarci di aver vinto” proferito di recente da un nome illustre della disciplina). Vergognarci no, ma conta anche il come. Scorrendo le pagine di questo libro, bisogna però ancora constatare che, com’era da aspettarsi, il drappello degli scrittori giuliani che, dopo aver vestito il grigio-verde, scrivono in italiano è fittamente rappresentato a spese delle altre lingue e delle altre divise. Un dato logico e scontato in un incontro soprattutto di italianisti. Non tanto ovvio forse il fatto che nessuno scrittore sia stato chiamato a farsi interprete della schiera degli oltre cinquantamila giuliani italofoni che difesero i colori imperiali in Galizia e sull’Isonzo, sul mare e come soldati della riserva. Il tema non è certo inedito, se ne sono occupati Lawrence Sondhaus (con un saggio che continua ad essere, per il periodo che precede la Grande Guerra, opera di riferimento: In the Service of the Emperor - Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918, 1990), Andrea Di Michele (Fra due divise - La Grande Guerra degli italiani d’Austria, 2018) e, con particolare attenzione al caso giuliano, Roberto Todero (Dalla Galizia all’Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella Grande Guerra, 2006). Mentre, da parte sua, Marina Rossi, non ha cessato di scavare negli archivi per una migliore comprensione di ciò che è accaduto sul fronte orientale, seguendo il labirintico dipanarsi dei destini (I prigionieri dello zar, 2011). Il fatto è però che, se è vero che la storia la fanno i vincitori, i giuliani di lingua italiana che servirono sotto la bandiera asburgica scelsero, al ritorno a casa, il silenzio (a differenza dei trentini, dove il patrimonio di diari e memorie della guerra per il Kaiser è potuto fluire con più libero corso e da cui ci si può ancora attendere qualche ampliamento d’orizzonte). La loro causa, sia stata difesa con entusiasmo, per intima adesione, per ossequio alle leggi dello Stato oppure semplicemente con la rassegnazione dei sudditi, ne usciva totalmente sconfitta. Amarezza, umiliazione, e forse, un sospetto di tradimento, accompagnavano il reinserimento dei reduci nella Trieste italiana. Per attenuare il contrasto tra fedeltà all’Impero e nuova appartenenza statuale delle terre d’origine nasce così la leggenda dei “demoghèla” o “pomigadori”. Quei negligenti, lavativi, disfattisti per convinzione, per farla breve i perfetti Sc’veik adriatici che sarebbero stati i soldati italofoni sotto bandiera austriaca, spina nel fianco dell’esercito di cui vestivano la divisa e quindi oggettivamente quinte colonne dell’Intesa (una leggenda smentita da tutti gli storici militari). Per altro, tacendo sugli anni in feldgrau, sbarazzatisi di mostrine, decorazioni e divisa, riponendo negli angoli di qualche cassetto le lettere che davano testimonianza della loro guerra (merito di Roberto Todero aver reso noto un carteggio particolarmente nutrito), avrebbero dovuto rassegnarsi a riconoscere la propria storia nelle pagine di chi, con ricca pietas e sicuro della propria scelta “giusta”, avesse voluto interessarsi al loro destino dimenticato. Un Giani Stuparich, per esempio, medaglia d’oro dell’Esercito italiano come il fratello Carlo, che dedica qualche capitolo di Ritorneranno alla vicenda di Domenico (in cui lo scrittore proietta molti tratti della figura paterna), soldato dell’esercito austriaco con tre figli, i protagonisti del romanzo, volontari in quello italiano: un uomo che ritorna a casa, racconta Stuparich, con “i segni di un crollo interiore”. Un unicum il volume di memorie di Antonio Budinich di Lussino (Budini dal 1937), stilato nel decennio 1939-49 e pubblicato nel 2013. Se sono forse ragioni di opportunità a suggerire gli incisi in cui l’estensore, ufficiale dell’esercito asburgico, dichiara la sua simpatia per la causa dell’Intesa (come pure ad avergli fatto “scordare”, come nota Adriano Andri, Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale, la decorazione ricevuta nel corso del conflitto), il diario è probabilmente il solo testo sulla guerra degli austro-italiani della Giulia in divisa austriaca che ci sia giunto completo, tracciando una parabola che inizia e finisce tra il ’14 e il ‘18, e non in forma di scaglie di memoria, incisi, allusioni, lettere – o brandelli di esse – rubati al macero e alla dimenticanza.
Scorrendo le pagine di questo libro, bisogna però ancora constatare che, com’era da aspettarsi, il drappello degli scrittori giuliani che, dopo aver vestito il grigio-verde, scrivono in italiano è fittamente rappresentato a spese delle altre lingue e delle altre divise. Un dato logico e scontato in un incontro soprattutto di italianisti. Non tanto ovvio forse il fatto che nessuno scrittore sia stato chiamato a farsi interprete della schiera degli oltre cinquantamila giuliani italofoni che difesero i colori imperiali in Galizia e sull’Isonzo, sul mare e come soldati della riserva. Il tema non è certo inedito, se ne sono occupati Lawrence Sondhaus (con un saggio che continua ad essere, per il periodo che precede la Grande Guerra, opera di riferimento: In the Service of the Emperor - Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918, 1990), Andrea Di Michele (Fra due divise - La Grande Guerra degli italiani d’Austria, 2018) e, con particolare attenzione al caso giuliano, Roberto Todero (Dalla Galizia all’Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella Grande Guerra, 2006). Mentre, da parte sua, Marina Rossi, non ha cessato di scavare negli archivi per una migliore comprensione di ciò che è accaduto sul fronte orientale, seguendo il labirintico dipanarsi dei destini (I prigionieri dello zar, 2011). Il fatto è però che, se è vero che la storia la fanno i vincitori, i giuliani di lingua italiana che servirono sotto la bandiera asburgica scelsero, al ritorno a casa, il silenzio (a differenza dei trentini, dove il patrimonio di diari e memorie della guerra per il Kaiser è potuto fluire con più libero corso e da cui ci si può ancora attendere qualche ampliamento d’orizzonte). La loro causa, sia stata difesa con entusiasmo, per intima adesione, per ossequio alle leggi dello Stato oppure semplicemente con la rassegnazione dei sudditi, ne usciva totalmente sconfitta. Amarezza, umiliazione, e forse, un sospetto di tradimento, accompagnavano il reinserimento dei reduci nella Trieste italiana. Per attenuare il contrasto tra fedeltà all’Impero e nuova appartenenza statuale delle terre d’origine nasce così la leggenda dei “demoghèla” o “pomigadori”. Quei negligenti, lavativi, disfattisti per convinzione, per farla breve i perfetti Sc’veik adriatici che sarebbero stati i soldati italofoni sotto bandiera austriaca, spina nel fianco dell’esercito di cui vestivano la divisa e quindi oggettivamente quinte colonne dell’Intesa (una leggenda smentita da tutti gli storici militari). Per altro, tacendo sugli anni in feldgrau, sbarazzatisi di mostrine, decorazioni e divisa, riponendo negli angoli di qualche cassetto le lettere che davano testimonianza della loro guerra (merito di Roberto Todero aver reso noto un carteggio particolarmente nutrito), avrebbero dovuto rassegnarsi a riconoscere la propria storia nelle pagine di chi, con ricca pietas e sicuro della propria scelta “giusta”, avesse voluto interessarsi al loro destino dimenticato. Un Giani Stuparich, per esempio, medaglia d’oro dell’Esercito italiano come il fratello Carlo, che dedica qualche capitolo di Ritorneranno alla vicenda di Domenico (in cui lo scrittore proietta molti tratti della figura paterna), soldato dell’esercito austriaco con tre figli, i protagonisti del romanzo, volontari in quello italiano: un uomo che ritorna a casa, racconta Stuparich, con “i segni di un crollo interiore”. Un unicum il volume di memorie di Antonio Budinich di Lussino (Budini dal 1937), stilato nel decennio 1939-49 e pubblicato nel 2013. Se sono forse ragioni di opportunità a suggerire gli incisi in cui l’estensore, ufficiale dell’esercito asburgico, dichiara la sua simpatia per la causa dell’Intesa (come pure ad avergli fatto “scordare”, come nota Adriano Andri, Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale, la decorazione ricevuta nel corso del conflitto), il diario è probabilmente il solo testo sulla guerra degli austro-italiani della Giulia in divisa austriaca che ci sia giunto completo, tracciando una parabola che inizia e finisce tra il ’14 e il ‘18, e non in forma di scaglie di memoria, incisi, allusioni, lettere – o brandelli di esse – rubati al macero e alla dimenticanza.
