|
IL BANCO DI LETTURA dal numero 33/2007 |
![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
RITRATTO D'AUTORE
PIETRO SPIRITO
a cura di Fulvio Senardi
estratto da CONTRIBUTI, dalla pagina 23 del n° 33/2007

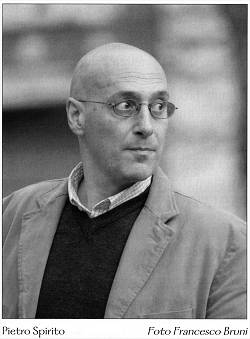 Anche
chi conosce Pietro Spirito soltanto per le vivaci “spalle” in
cui commenta romanzi, libri di viaggio, racconti sul giornale quotidiano di
Trieste (e sono i più, in un Paese di non-lettori che si accontentano
di sbirciare frettolosamente il giornale fra un sorso e l’altro del
caffè, al bancone dei bar) non stenterà a credere che si tratti
di uno dei più brillanti giovani narratori del Nord-est. Uno scrittore
dal percorso ormai tanto ricco da consentire, a chi di letteratura si occupa
professionalmente, di individuare, con le costanti di pensiero e i modi di
stile, le sfaccettature di una poetica: in breve, con tutte la cautele del
caso, di stilare un bilancio. Lo si farà, nelle pagine che seguono,
privilegiando alcuni libri più rappresentativi, quelli che hanno maggiormente
marcato la sua ricerca di narratore, presentando solo in nota una bibliografia
più completa.
Anche
chi conosce Pietro Spirito soltanto per le vivaci “spalle” in
cui commenta romanzi, libri di viaggio, racconti sul giornale quotidiano di
Trieste (e sono i più, in un Paese di non-lettori che si accontentano
di sbirciare frettolosamente il giornale fra un sorso e l’altro del
caffè, al bancone dei bar) non stenterà a credere che si tratti
di uno dei più brillanti giovani narratori del Nord-est. Uno scrittore
dal percorso ormai tanto ricco da consentire, a chi di letteratura si occupa
professionalmente, di individuare, con le costanti di pensiero e i modi di
stile, le sfaccettature di una poetica: in breve, con tutte la cautele del
caso, di stilare un bilancio. Lo si farà, nelle pagine che seguono,
privilegiando alcuni libri più rappresentativi, quelli che hanno maggiormente
marcato la sua ricerca di narratore, presentando solo in nota una bibliografia
più completa.
“Il 24 settembre 1719, all’età di ventinove anni, Pierre
Dumont, commerciante di gioie, dopo aver a lungo vagato e conosciuto gli uomini
e i loro inganni, s’accordò in società con Dio”.
Così l’attacco, che riassume l’esile filo conduttore, del
breve romanzo di Pietro Spirito, Vita e sorte di Pierre Dumont socio di
Dio, il primo dei libri che prenderemo in esame. La vicenda, che non
ha la ramificata apertura romantica di un’opera-mondo, ma, come vuole
l’epoca dell’ambientazione, corre su un rettilineo – e sorridente
– crinale swiftiano, racconta di come Pierre Dumont, mercante intraprendente
ma non sempre, ahilui, baciato dalla sorte, si fosse deciso a fare società
con Dio. Se la decisione scaturisse da un guizzo dello spirito di carità
acceso in Pierre da padre Carnesecchi della Compagnia di Gesù, che
tante parte aveva avuta nella sua educazione, o provenisse da un piccolo e
forse inconsapevole calcolo opportunistico, che non ripugna anche ai mercanti
più timorati di Dio, rimane avvolto nel dubbio; come prevede del resto
il modulo narrativo cui Spirito fa garbatamente il verso e che non richiede
quelle spietate incursioni nell’Io cui ci ha abituati il romanzo di
introspezione. Fatto sta che Dumont, con tanto di contratto firmato e bollato,
rende solenne promessa di cedere a Dio, cioè ai bisognosi, la metà
dei propri guadagni. Impegnando a ciò anche i suoi eredi. Caduto vittima
di un mortale incidente all’età ancor giovane di 35 anni (la
scena che, nelle ultime pagine del libro, descrive l’accaduto, forse
addirittura un omicidio visto che al timone della carrozza che lo bracca,
lo raggiunge, lo schiaccia Pierre intravede la sagoma lugubre di un rivale
in affari: “gli parve, gli sembrò la torva figura dell’Alsazo”,
ha il cupo rimbombo di certo Settecento rivisitato dagli scrittori romantici),
l’obbligazione assunta dal defunto diventa affare della moglie, Laurette,
e del figlio Jean-Paul. Di fronte a loro, reticenti a concedere quanto dovuto,
si ergono invece a esigere pieno e pronto rispetto delle clausole contrattuali
gli avvocati del parigino Ospitale Generale, l’istituzione cui è
demandato un officio di assistenza e di beneficenza. Da qui una causa in tribunale
fra le più singolari e curiose perché si tratta di decidere
che cosa spetti a Cesare e che cosa a Dio, anzi, più sostanzialmente,
se sia lecito all’uomo fare società con il Signore e che atteggiamento
debba assumere la legge di fronte a un impegno così inconsueto e imbarazzante.
Le diverse interpretazioni del quesito nella prospettiva di una giurisprudenza
che i contrapposti avvocati cercano di addomesticare a proprio favore, vengono
poste, come una ricorrente e ben evidenziata cifra iniziale, in testa a ciascuno
dei capitoli che raccontano le tappe sfortunate della carriera del commerciante
Dumont; e la sua vicenda, ripercorsa a ritroso, non solo guadagna, così
incorniciata, un’ulteriore ragione di unità ma finisce per vibrare
del peculiare accordo che proviene da un linguaggio di burocratica cavillosità
e di avvocatesca pedanteria con acquisto, anche in questo caso, di un arcobaleno
di sfumature ironiche. Considerando questo aspetto si potrebbe addirittura
sostenere che la particolare scelta di scrittura miri precisamente a ostacolare
con tutti i possibili mezzi i processi di identificazione (assimilando anche
in questo caso, e con indiscutibile abilità, un aspetto della narrativa
settecentesca, in netta controtendenza rispetto all’“appendicismo”
che trionfa, a tutti i livelli, nella narrativa contemporanea), con una messa
a fuoco carica di sottintesi ironici che distanzia il protagonista, ridotto
potremmo dire alle dimensioni di un insettino intrappolato dentro una goccia
d’ambra. Aleggia infatti sopra di lui, come funzione di un capriccioso
e irridente dio creatore, uno sguardo narrativo tanto sornione e divertito
quanto poco appassionato e partecipe.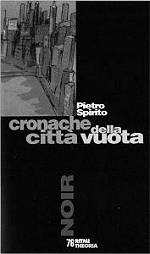
Che l’ironia sia il tono dominante del racconto (e che l’interpretazione
debba necessariamente prenderne atto) lo documentano in effetti altre spie:
di ordine contenutistico, in primo luogo, e penso, solo un esempio, all’inaspettato
risvolto di poeta amoroso che viene attribuito all’altrimenti retto
ed ascetico padre Carnesecchi; o al modo nel quale vengono disegnati i personaggi,
con un tratto netto, ma tutto di superficie, come certe figurine nella pittura
del secolo, e le cui ombre di tormento sono risolte in sorridente giocosità
da un narratore che, ariostescamente, tutto domina, planando sul mondo come
da limpide altezze. Oppure, ancora in tema di ironia, la si può facilmente
riconoscere negli epiteti che definiscono la personalità del protagonista,
mettendo volta per volta in rilievo un suo particolare modo di essere, così
da farci incontrare ora il pauvre Pierre, ora un Pierre l’aventurier,
e poi, via via, Pierre amoureux, honnete, malhereux, ecc. Momenti
variati di un’esistenza che nelle sue fasi alterne mette in luce diverse
qualità, stati d’animo, inclinazioni; non certo novecentesche
maschere dell’Io, a celare una censurata o inibita identità originaria,
ma forme di una mutevolezza senza tormento né angosce, come ci si attende
da un Settecento insieme razionalistico e lezioso, che ama bautte e giochi
da salotto, al tempo stesso picaresco e libertino, e da un personaggio che,
per quanto non alieno da pietistico timor di Dio, non sa negarsi alla curiosa
scoperta del mondo, come vuole una Modernità ai primi passi, avida
più di ogni altra cosa di conoscenze e di esperienze (il “tanto
moto, tanta gioia” celebrato da Sterne). Un mondo che si manifesta per
nervature e midollo, come successione di episodi e storie nella storia, e
scenari e mises en abîme di sapore appropriatamente settecentesco
e teatrale. Da qui un consistente numero di parentesi narrative che, deliziosamente
circoscritte, sanno colpirci senza travolgerci, come se osservassimo un cammeo
di elegantissima fattura capace di parlare, più che al cuore, al nostro
senso estetico: le pagine che raccontano, per esempio, la scoperta dell’amore
da parte di Pierre fra le braccia quasi materne di Violette; il ritrattino
di Serafio, compagno del protagonista nel suo viaggio verso le Americhe (dove
anzi sembra quasi di poter riconoscere una riflessione sulla natura linguistica
del romanzo stesso, visto che le storie di Serafio, che “pure sa farsi
intendere al meglio, avendo la sua loquela un non so che di persuasivo”,
sono “narrate in verità in un idioma mai prima udito, ove si
mesciano le favelle di tutte le genti conosciute”); la paginetta che
descrive l’incontro con le balene, compresa anche questa nella parte
del volume che incastona il sapido giornale di viaggio di Pierre Dumont, dove
pare quasi di cogliere lo stupore metafisico di un secolo a metà strada
tra Arcadia e razionalismo, nell’attimo in cui intuisce la forza profonda
e travolgente di quella tensione cosmica e interiore che molto tempo dopo
l’uomo chiamerà brama o libido:
Ieri vedemmo una balena, la prima (…) Da alcune notti
esse ci tengono desti coi loro lamenti, che i marinai dicono essere affanni
d’amore. Io dapprincipio rimasi alquanto impaurito da questo pianto,
un suono come mai avevo udito e che ritengo alcuno istrumento di umana fattura
possa mai imitare. Sibbene, io credo, vi possano pur essere pene d’amore
tali da costringere l’animo nostro a un sì potente dolore, un
piagnimento vasto inverso il mondo tutto, quasi a voler chiedere a Iddio medesimo
di por almanco fine a questa febbre e bramosia.
Ma poi, ciò che si può nomare canto mi è sembrato meno
spaventoso, e anzi vi odo un che di meraviglioso, e provo uno struggimento
confortante, come se questo canto raccomandasse di non aver timori degli abissi
oscuri, gelidi e profondi e densi degli oceani, ché anzi vi è
dolce penetrarvi e scendere al fondo, come perdersi in un gran sonno. Più
che mai, odo in quei lagni, Dieu seul est mon témoin.
Il lungo passo citato, forse la pagina più suggestiva del libro,
nutrita com’è di una particolarissima sostanza sentimentale,
ci mette in stretto contatto con lo stile del romanzo, libero da ogni soggezione
realistica e assai lontano dallo scorrere dimesso di codici solo comunicativi.
In effetti il racconto celebra la sua apoteosi in quanto manufatto linguistico:
sarebbe lungo e noioso stilare un glossario delle parole rare, tecniche, arcaiche
e letterarie di cui è il gremito palcoscenico, ma si potrebbe almeno
cominciare, a mo’ di esemplificazione, dalla prima lettera dell’alfabeto.
Con sorpresa allora toccherebbe registrare il quattrocentesco acchinare
(umiliare, lasciarsi persuadere), documentato in San Bernardino, il guittoniano
affaitare (francesismo di antico conio che vale per adornare), il
boccacciano e quindi romantico (ma di rarissimo impiego) ajato, nell’espressione
“andare ajato” cioè gironzolare. C’è in tutto
ciò, con evidenza palmare, l’impronta di Consolo, il maestro
del contemporaneo scrivere difficile dei narratori, ma ciò che non
fa per nulla spiacere la maniera di Spirito è il retrogusto ironico
che smussa con un sorriso accomodante il filo tagliente del trobar clus
dello scrittore siciliano. Continuando gli assaggi si scoprirà assai
presto che la lingua messa in opera da Spirito non trova la sua legittimità
sul versante filologico (manca ogni intenzione di elaborare un universo linguistico
di sostanza storicamente coerente), bensì su quello scapigliato della
fantasia: il parlare artificiato della Vita e sorte profuma di falso
antico; il suo preziosismo, distillato per alambicchi vocabolaristici, e con
tanta perizia da sembrare il prodotto di una verve charmante, certo,
ma naturale, non cerca in alcun modo di nascondere l’inganno perché
ci vuole partecipi, anzi, complici del proprio gioco erudito. La sfida arcigna
e intransigente di Consolo, intesa a denunciare con l’asprezza di un
sillabare aulico la sciatteria dei gerghi di massa si volge in Pietro Spirito
in un eccitante prurito (come la malattia psico-somatica del protagonista),
chiamandoci a godere la garbata verve antiquaria della scrittura. Siamo nel
Settecento, per Bacco, ed ogni impuntatura risentita parrebbe del tutto fuori
luogo. Un Settecento contraffatto come sui passi di danza di certi Rosenkavalieren
fin-de-siècle, tutto interno alla magia della letteratura, ma
senza un filo di supponenza, e che profuma, sentore magnifico, di teatro e
di fiaba. Certo, a scavare dentro le intenzioni, non potrà sfuggire
che la passione lessicografica di Pietro Spirito (nulla a che fare con il
delirio carnale di un D’Annunzio) è il rovescio della medaglia
di una inclinazione “ecologica”, di una testarda volontà
difensiva che, senza sfogarsi in esplicite denuncie (ne hanno scritte di assai
taglienti La Capria e Consolo), si nutre delle parole della tradizione per
riaffermarne i valori, in un Paese la cui quotidianità espressiva è
ormai tanto degradata che non è difficile sentirsi dire frasi del genere:
“la privacy è un optional” o “”un ticket per
il day hospital”, e via sproloquiando. Grazie dunque Spirito, per averci
mostrato come la narrativa possa spendersi, fra gli altri infiniti compiti
che le spettano, in una missione di moralità elementare, che significa,
innanzitutto, rispetto della lingua, il patrimonio di noi tutti.
Alcuni anni dopo un nuovo libro, e con esso una consistente evoluzione: si
tratta delle Indemoniate di Verzegnis (2000), dove Spirito ci offre
la cronaca romanzata di un misterioso episodio dell’estremo nord-est
d’Italia: in un angolo della Carnia ottocentesca si intrecciano miseria
e superstizione, inquietudini femminili, agoscianti come le rupi ed i boschi
che rinserrano il minuscolo paese, e maneggi interessati di notabili locali,
laici ma soprattutto ecclesiastici. La posta in gioco è l’egemonia:
egemonia sulle coscienze che può propiziare conquiste più redditizie,
in campo politico e civile. A questo fine giungono dunque utili anche i deliri
isterici delle “indemoniate di Verzegnis”, fenomeno di psicosi
collettiva degno dell’attenzione di Lombroso (o della penna di Huxley,
quello dei Diavoli di Loudun, per intenderci), ma metafora, nella
prospettiva di Spirito, di una patologia sociale irrimediabilmente cronica
nel nostro Paese, di cui si cerca di isolare alcuni dei nodi centrali; sempre
però con la mano sapientemente leggera di chi conosce, e ha meditato,
l’esempio di Sciascia. Così, senza rinunciare all’arcobaleno
di possibilità offerte dal romanzesco, senza abdicare alla fascinosa
“reticenza” della parola letteraria, lo scrittore ci guida per
mano in un severo esame della società italiana da sempre lacerata tra
tentazioni regressive e spirito di progresso, tra esigenze legate al “particulare”
e dedizione (scarsa) all’interesse collettivo, tra volontà rabbiosa
di conservare e impegno, spesso velleitario, di cambiamento. Dramma che continua
ancor oggi, oggi anzi più che ieri, a quanto insegna la cronaca politica
(che ha visto un magnate dei Media scendere rumorosamente in campo per difendere
i propri interessi di bottega e monopolizzare il dibattito politico con gli
estenuanti tiri alla fune con la magistratura); una situazione di fronte alla
quale Spirito, pronto a tirarsi da parte per lasciar parlare i fatti, evita
tanto la polemica urlata, quanto atteggiamenti di qualunquistica, se non complice
rassegnazione. Oltre a questo assillo etico-politico, il libro esibisce un
consistente versante di ricerca d’espressione: è la scrittura
che si nutre di se stessa, che celebra la liturgia avanguardistica dell’autonomia
del significante. Ecco quindi che in un contesto di stile sempre di alta qualità
letteraria, si accendono improvvise le fiamme di un amore di parola (più
cerebrale che sensuale, più filologico che estetizzante) consapevole
e praticato, e la narrazione derapa (ma senza mai precipitare!) lungo una
impervia china “gaddiana”. Una fitta selva di vocaboli rari, di
espressioni disusate, tecniche, arcaiche o letterarie, vena la pagina con
ramificata capillarità, creando un intreccio di ironiche contaminazioni,
di eruditi riciclaggi, di vocabolaristiche elencazioni, proprio come nel settecentesco
divertissement costruito intorno al destino di Pierre Dumont: vi trovano posto,
per limitare i prelievi al solo primo capitolo, il letterario “fugare”,
il raro “ombrato” (per “offuscato”), il desueto “brividìo”,
l’arcaico e dantesco “divimare” (per “sciogliere”),
il colto “volitare”, il raro “urtamento”, ecc. ecc.
Cascata di gioielli che precipita, più di sovente, a gruppi triadici,
con effetti non sempre felicissimi visto il loro meccanico ricorrere: e così
Giovan Battista, uno dei personaggi, verrà descritto come virtuoso
“di bietta, chiavaccio e mazzapicchio”, Verzegnis apparirà
“assente, distante, immiserita” (ivi), perché gli echi
del mondo vi giungono “attutiti, flebili e uggiosi: un mormorio sommesso,
strisciante e talvolta foriero di vaghe sventure” (ivi), e così
via. Grappoli di sinonimi non certo spaesati o dissonanti, ma sicuramente
tangenziali rispetto alla curva del narrare: punti di convergenza di fiction
e filologia, a ricordare che la letteratura è anche tecnica, manufatto,
artificio di parole, e a suggerire, dietro la maschera troppo corriva e modaiola
dello scrittore “ispirato”, un io operativo e manipolatore; l’effetto
di straniamento è così assicurato, il mito della naturalezza
del segno demistificato, l’immedesimazione - ambiguo nume della moderna
fiction di intrattenimento - messa alle corde, il ritmo delle vicende
sapientemente rallentato, disattivato infine il meccanismo di “speculazione
sull’effetto” in cui T. W. Adorno ha riconosciuto, già
negli anni Sessanta, il carattere saliente dei prodotti della cultura di massa.
Il mestiere, comunque, non è tanto prepotentemente esibito da inceppare
quella consistente, e non tanto segreta, vocazione civile di cui si è
parlato poc’anzi. In fondo, e ciò può concludere l’analisi
del libro, è proprio questa la sfida da vincere per un filone che lega
la propria identità a forme avanzate di ricerca espressiva: appropriarsi
di quello spazio di consapevolezza civile e di spessore umano che separa il
divertissement dall’arte autentica. Trasformare il gioco delle
forme - proprio perché non resti solo gioco - in uno strumento di indagine,
in uno scandaglio nel mistero dell’uomo e nelle dissonanze della società,
colmando quello iato tra la letteratura e la vita che è l’abisso
dentro il quale affondano molti libri impacciati da una zavorra di arabeschi.
Dovranno passare tre anni prima che appaia nelle librerie un nuovo libro di
Pietro Spirito; quello Speravamo di più (2003) che gli conquisterà
un posto nella cinquina dello Strega. Ed è un incontro con uno scrittore
che non conoscevamo. Avvezzi ai virtuosismi espressivi di chi si dichiarava
discepolo di Consolo e del grande Gadda, la nuova maniera di Pietro Spirito,
uno stile semplice e cordiale, ci mette di fronte a un brusco cambiamento
di rotta. Interessante metamorfosi in una stagione in cui l’evidente
impegno di molti scrittori consiste in una specie di fedeltà a se stessi,
specialmente se ciò significa sfruttare fino alla nausea una formula
di successo, granitica come le lapidi dei cimiteri. Leggete un libro della
Tamaro, di Baricco o di De Carlo, o peggio ancora, un romanzo di Camilleri,
ed è come averli letti tutti: triste deriva seriale della narrativa
dell’età di massa. Del resto ci vuole coraggio per cambiare,
di fronte ad un pubblico pigro che nella lettura, più che uno stimolo
a riflettere, vuole conferme per consolanti abitudini. Ecco invece, come si
diceva, lo stile semplice e cordiale del nuovo libro di Spirito, cosa che
non equivale per nulla a pressappochismo e sciattezza. É fare andare
invece il motore di potenza, piuttosto che imballarlo in laceranti fuori giri:
stile, in altre parole, maturo e consapevole. Chi sa scoprire nella rinascita
di Borgo Sant’Aquila, il paesino dell’ambientazione, un’“atmosfera
sfrigolante”, o coglie, nel carattere del nuovo parroco, una capacità
di visione “levigata e conclusiva” non può passare per
uno scrittore povero di mezzi; al contrario un narratore sobrio per scelta
responsabile, che si è deciso ad imboccare una strada di castità
espressiva riconoscendovi una forma intrinseca di moralità, e va così
adeguando la scrittura ad una nozione, né invadente né gridata,
di impegno etico, di passione civile; quell’orizzonte che già
nel libro precedente conferiva al racconto una tonalità particolare,
un retroterra dal sapore “buono”. La curiosità per i linguaggi
e per le sfaccettature dell’espressività, che non si sfoga per
canali “gaddiani”, trova invece la strada dei riporti dialettali,
un modellarsi, in termini diremmo “sociolinguisitici”, dell’interesse
di Pietro Spirito per l’uomo in specifici contesti della vita sociale:
la sua prosa non cessa così di “spumeggiare”, ma senza
effetti di ubriacatura, come un invito semmai a pacate riflessioni. Il racconto
è incalzante e compatto, lo sostiene un’invenzione astuta: tallonare,
con occhio affettuosamente attento, il lento inserimento di uno straniero,
per l’esattezza un giapponese, in un borgo della fascia prealpina, negli
anni del secondo Dopoguerra e del successivo “miracolo economico”.
Borgo destinato ad essere sorpassato dalla storia, a deperire di disoccupazione
e spopolamento, e quindi metafora dell’inevitabile tramonto di modi
di vita poveri ma schietti, a sparire fagocitato dalle acque di una diga che
produrrà energia per la città. Il giapponese, o meglio il “cinese”
come recita la voce narrante facendo eco al comune sentire di un ambiente
che vive ancora di leggende e di stupori, offre la possibilità a Spirito,
e al personaggio che ne è portavoce, di vedere le cose dal di fuori,
di offrire, ai lettori che sono figli, o vittime, di trasformazioni radicali
e snaturanti, uno specchio fedele del più recente passato: uno specchio
che restituisce il volto vero, strappando la maschera dell’ovvio, a
processi sociali ed economici che hanno cambiato alla base, e non sempre in
meglio, consuetudini di vita, pensieri e coscienze, immaginario e senso morale.
La seconda parte del romanzo, quasi a rendere concreto il raccordo tra i destini
e la Storia, allinea, in brevi lacerti di cronaca, alcune emblematiche tappe
delle “magnifiche sorti e progressive”: l’arrivo del frigorifero,
la diffusione della televisione, dei flipper e dei juke-box perfino nei baretti
di paese, la discesa dell’uomo sulla luna, il computer, intorno al quale
si affanna il protagonista, negli ultimi capitoli del libro e il cui ronzio
fornisce la cornice, quanto mai appropriata, all’incontro d’amore
che definitivamente lo traghetta (o lo scaglia?) nella “modernità”;
causando cambiamenti sempre più frenetici il progresso si allarga in
vortici tumultuosi, mentre la speculazione e l’affarismo lo pilotano
verso esiti spesso catastrofici. Volevamo di più dà
voce alla rassegnata coscienza di chi è consapevole di un’occasione
perduta, di una possibilità di crescita concorde ed armoniosa di beni
materiali e di coscienze; una possibilità a cui proprio il “cinese”
sembra garantire concretezza, con l’istintivo senso di equilibrio di
un popolo che da secoli vive nel rispetto delle proprie tradizioni, facendo
della disciplina interiore (da qui il motivo delle arti marziali) una sorta
di laica religione che avvicina l’uomo al mistero dell’Essere.
Tuttavia nulla di ciò che avrebbe potuto si è effettivamente
realizzato: la modernità ha ceduto alla maledizione che la perseguita.
Il penetrante occhio orientale che Junichiro spalanca sull’Italia del
“miracolo economico”, occhio di testimonianza e di denuncia, si
spegnerà così misteriosamente (l’uomo scompare e chi scrive
l’accorato memoriale non cessa di cercarlo, nei luoghi della loro vita
e nelle pieghe di ricordi che non si rassegnano a morire) dopoché si
sarà chiusa, lasciando solo una traccia di “fango” (è
il titolo dei due capitoletti, che suggellano, all’inizio e alla fine,
la parabola del racconto), la circolarità del libro; un percorso che,
nel segno devastante di un cupo trionfo del “progresso” (la tirannia
della tecnica, direbbero i seguaci di Heidegger), collega i disastri della
guerra ai trionfi della follia speculativa, facendo incontrare Hiroshima e
il suo fungo letale con il disastro della fabbrica spregiudicatamente piazzata
dalla Chemical & Polimeric Corporation proprio a ridosso di Borgo Sant’Aquila.
Già dalle prime battute del romanzo, del resto, si era annunciato con
forza il tema della inconciliabilità tra natura e destino occidentale,
nella riflessione di Junichiro, e sono pagine belle e profondamente meditate,
sulle pietre di Venezia; trionfo provvisorio della dura materia sull’elemento
acquoreo, condotto in direzione opposta a ciò che suggerirebbero le
filosofie orientali (assecondare la forza dell’avversario per poterlo
infine sconfiggere: le case di legno e di tela sui fianchi di inquieti vulcani);
una breve vittoria sulla natura cifrata nella fioritura straordinaria ma effimera
di architetture sontuose, destinate a veder presto corrosa, dalle forze del
mare, la loro granitica bellezza. Con perfetta coerenza, dopo uno straniato
vagabondare, il “cinese” sceglie allora di vivere là dove
la contesa fra l’uomo e la natura sembra ancora aperta, nella forma
di un faticoso armistizio, ai margini dei monti, fra i boschi che impennacchiano
i contrafforti prealpini.
Ed è proprio in quei luoghi, dove l’esistenza quotidiana è
un andare sofferto fra i disagi, che Junichiro intreccia indelebilmente la
sua vita a quella di giovani spaesati e indolenziti da una realtà in
brutale transizione. Va così a sciorinarsi un ventaglio di destini,
una delle cose più belle di questo libro: sintetici ritratti di umanità
“minore” le cui esistenze disegnano suggestive silhouette intarsiando
il racconto di allusive lateralità, quasi un affresco collettivo, o
una foto di gruppo tratta dal liso tascapane del passato. Un pulviscolo di
storia e società, martoriati brandelli di vissuto che, pur di corposa
concretezza, sfuggono ad ogni sovrappeso realistico, dal momento che molti
dei personaggi rivestono una funzione emblematica, un impegno che li alleggerisce,
senza tuttavia farli scivolare in una pura allegoria: c’è il
politicante corrotto, dalla riconoscibilissima appartenenza, il ragazzo traviato
che si riscatta nel lavoro e nella disciplina delle arti marziali, la ragazza
di paese che un triste destino di violenza ha come intrappolato in una adolescenza
attonita ed innaturale. La formula “volevamo di più”, con
il senso di perdita e di nostalgia che trasmette, vale così anche ad
indicare l’irrecuperabilità dei giorni trascorsi, la meravigliosa
sostanza di una stagione che ha irripetibilmente accordato speranze individuali
e collettive, a poco a poco sbiadite, mentre, alla ricerca del meglio, ci
si è negati alla felicità. La riflessione della voce narrante,
nel capitoletto intitolato “Fuoco” (invano ho cercato, e non potevo
trovarlo, quello dedicato all’“aurora”), a proposito di
Barbara, la donna amata, che “mi avrebbe dato dei figli. Loro avrebbero
avuto un mondo migliore”, può valere come suggello di questo
libro tenero e amaro, abilmente giocato sul doppio registro del personale
e del sociale, pulito e onesto come il “cinese” di cui racconta
la “biografia” italiana: un’altra generazione si prepara
a ripetere gli stessi errori, a costruire sulla disarmonia, su quel miraggio
di opulenza che dà risposte solo provvisorie alle più autentiche
necessità interiori. Certo, sappiamo che per salvarci non basterà
prestare orecchio alla voce del “cinese” (per quanto, curiosa
coincidenza, abbia visto la luce proprio nei giorni dell’uscita del
libro, un testo di Simone Weil mai tradotto prima in italiano, che additava
l’esempio dell’Oriente come antidoto alla “smemoratezza”
occidentale). Romanzo inutile, allora? - solo una riflessione disperata? No,
perché nulla appare più essenziale, nell’incertezza dell’attuale
transizione, in quel vacuo giardino di delizie che è ormai la letteratura
alla moda, di ciò che ha il potere di svelarci a noi stessi. Di renderci
ancora capaci, spiazzati come siamo tra rovine e miraggi, tra speranze annebbiate
di futuro e un presente sporco come il fango, di resistere all’indifferenza,
dandoci di nuovo la forza, è proprio il caso di dirlo, di “volere
di più”.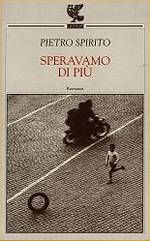
Che Pietro Spirito abbia oramai deciso di misurarsi con il presente, affrontando
quei nodi etici, gnoseologici, culturali che appesantiscono il nuovo millennio,
anche in casa nostra, di prospettive assai minacciose, lo dimostra l’ultimo
dei suoi romanzi, Un corpo sul fondo, pubblicato da Guanda in questo
stesso anno (2007). Libro che spicca, rispetto ai precedenti dello stesso
autore, anche per la particolare veste tipografica: lo corredano infatti fotografie
e disegni (oltre che un corposo bagaglio di note storiche e tecniche, abilmente
ricondotte ad una misura linguistica di cordialità comunicativa), quasi
a sottolineare l’impegno documentario che il romanzo si è assunto,
proprio mentre va a sfiorare un tema quanto mai complesso, con cui il libro
civetterà senza mai condurlo a soluzione, quello etico-politico della
“verità” in relazione alla memoria. Vi si racconta, per
venire al soggetto, il tentativo di ricostruzione da parte di un giornalista
dei nostri giorni del disastro avvenuto al largo di Pola nel 1942 del sommergibile
italiano Medusa, in esercitazione nelle acque dell’Istria.
Sorpreso da un sottomarino nemico era stato affondato, intrappolando nella
propria carcassa quattordici uomini che non sarebbe stato possibile mettere
in salvo in alcun modo, nonostante gli sforzi dei soccorritori. A motivare
le ricerche del giornalista, trasparente alter-ego dello scrittore (che in
questo romanzo, come mai prima nei libri precedenti, modella il narratore
sul proprio profilo professionale ed umano), un reduce della guerra, tale
Domenico, per il quale “passato e presente [sono] un istante unico”.
Mosso da oscuri sensi di colpa, di cui il romanzo svelerà a poco a
poco le radici, Domenico vuole sapere: sapere se ci sono stati sopravvissuti,
sapere a chi vada attribuita la responsabilità del mancato salvataggio,
sapere dove giacciono i corpi dei caduti. Inizia qui la lunga spirale di una
perlustrazione che coinvolge il narratore-protagonista molto più profondamente
di quanto non vorrebbe, toccando in lui tasti psicologici ed umani che lo
portano alle soglie dell’incubo, ne scatenano la violenza, finiscono
quasi per incrinarne il senso di identità: nella sua ricerca verrà
a conoscenza di altre navi naufragate in quelle acque, di cui sono testimonianza
resti che ormai il mare ha irrimediabilmente assimilato: storia che ridiventa
inesorabilmente natura. Non quelli del sommergibile Medusa però, che
sarà impossibile ritrovare, come le tombe dei marinai caduti, che pure
i registri delle sepolture affermano inumati in un cimitero di Pola. Il gioco
condotto da Spirito è sinuoso e sottile: il giornalista è, o
almeno dovrebbe, risultare psicologicamente immune ai più pressanti
contraccolpi della sua inchiesta; eppure si lascia a poco a poco prendere,
come contagiato dalle indecifrabili smanie di Domenico e della sua affascinante
amica, la giovane Vera. La Storia, quella storia, rimane tuttavia per lui
chiusa nei limiti dei documenti ufficiali e dei reperti, il guscio vuoto ed
inerte di vicende di cui solo coloro che le hanno vissute possono cogliere
la vera sostanza umana. Di fronte a lui Domenico, interprete invece di una
memoria dolorosamente personale, un grumo che egli vorrebbe sciogliere ritrovando,
quasi con funzione catartica, il filo di quel lontano passato; a sua volta
intrappolato in una prospettiva parziale delle vicende, parziale e relativa
come ogni ricostruzione che abbia come punto di partenza la visuale ristretta
di una singola esperienza umana. I due approcci non comunicano né riescono
ad integrarsi, entrambi necessari, ma nessuno, preso per sé, risolutivo.
Com’è possibile, si chiede Domenico in un momento cruciale dell’intreccio,
che “dei miseri pezzi di carta potessero dire a lui com’era stata
la sua vita, che cosa era successo allora”? Senza che questa consapevolezza
lo faccia desistere dal tentativo di trovare, aiutato da chi per mestiere
fa la cronaca della città, quelle tracce e quelle testimonianze che
potrebbero dare finalmente ai ricordi sostanza concreta e inconfutabile, dissipando
gli incubi che suggerisce una fantasia sempre più cupa. E’ tragico,
in questo senso, il romanzo di Spirito, nonostante lo stile affabile, la scorrevolezza
narrativa, l’ammirevole capacità di ricondurre a forme di leggibilità
gradevole anche i passi più tecnicamente impervi, laddove cioè
si descrivono, e non se ne potrebbe fare a meno, le caratteristiche tecniche
e militari dei sommergibili classe Medusa. Tragico e insieme tempestivo: mai
come in questo momento la memoria, collettiva e individuale, è diventata
tema rilevante, sulla ribalta politica europea, sia in prospettiva politico-ideologica
che morale. Abbattuti gli idoli di ideologie totalizzanti gli uomini avanzano
richieste di riconoscimento per il proprio dolore, per quella sofferenza storica
che era rimasta senza voce per colpa degli steccati di dogmi e pregiudizi:
il ricordo va indietro, ai tragici fatti che seguirono la seconda guerra mondiale,
alle lacrime dei vinti, alle colpe dei vincitori, ai massicci trasferimenti
di popolazioni che hanno alloro brutalmente ridisegnato la mappa etnica d’Europa.
Una memoria rimossa rientra in gioco, mettendo in crisi i dati ufficiali della
conoscenza storica, le convenienze del discorso politico, i valori stessi
dell’identità collettiva (proprio ora che sentiamo il bisogno
di una sguardo finalmente “europeo”). Ogni cosa va ripensata in
relazione a un nuovo baricentro, prendendo atto di sofferenze a lungo sottaciute,
ma resistendo – qui lo scrittore tace ma lascia perfettamente intuire
– a quei subdoli revisionismi che vorrebbero tutto “imbiancare”,
perfino la barbarie nazi-fascista. Pietro Spirito, come ogni narratore autentico,
ha “annusato l’aria”, individuando uno dei temi cruciali
della nostra epoca, ed è andando tessendo, come una figura di metafora,
il suo ultimo romanzo. In esso il problema viene, per così dire, impostato,
richiamando la nostra attenzione sulla complessità di esigenze individuali
e collettive che non possono essere eluse. L’ultima scena è emblematica:
la ricerca si chiude nel cimitero di Pola dove le tombe dei marinai caduti
risultano introvabili; Domenico è stanco e deluso, cede i fiori che
portava al narratore, con un movimento brusco, ultimativo.
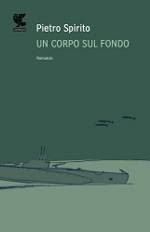 Diedi
un’occhiata intorno per vedere se qualcuno ci stesse osservando. C’era
solo un’anziana signora, di spalle, in lontananza. Mi trovavo in un
settore dove, a giudicare dalle lapidi, erano sepolti insieme cristiani, musulmani,
ebrei in un coagulo di nomi italiani, croati, tedeschi, serbi, bosniaci, sloveni.
Con un gesto rapido gettai i fiori a caso fra le tombe.
Diedi
un’occhiata intorno per vedere se qualcuno ci stesse osservando. C’era
solo un’anziana signora, di spalle, in lontananza. Mi trovavo in un
settore dove, a giudicare dalle lapidi, erano sepolti insieme cristiani, musulmani,
ebrei in un coagulo di nomi italiani, croati, tedeschi, serbi, bosniaci, sloveni.
Con un gesto rapido gettai i fiori a caso fra le tombe.
Il romanzo sembra afflosciarsi in una chiusa sommessa, anzi quasi rinunciataria, se la confrontiamo con il serrato procedere di un libro sempre capace di tener desta l’attenzione. In realtà essa esprime, con quel suo studiato grigiore, l’amarezza di una presa d’atto – vi sono cose del passato che non potranno mai riprendere colore, mai risorgere pienamente alla luce –, e insieme ad essa il sollievo di una speranza. Se è innegabile che importa capire ciò che è stato (e che non è quindi inutile lo sforzo degli storici), più necessario ancora è un atteggiamento di pietas verso ogni forma di dolore umano, quel dolore che continua inesorabilmente a governare la nostra vicenda terrena, nel corpo a corpo con il tempo e la vita, la Storia appunto (non sarà sfuggito ad una lettura attenta che verso la fine del libro Spirito fa scivolare nel racconto un nuovo tema, anzi, nuove immagini, quelle angoscianti della guerra civile jugoslava). E dolore che, refrattario ad ogni semplificazione ideologica, sudario che avvolge ed accomuna tutti i percorsi individuali, anche quelli del ricordo e della memoria (che dobbiamo probabilmente rassegnarci a concepire “divisa”, ancorché non necessariamente conflittuale), può rappresentare un terreno di conciliazione, un primo passo verso orizzonti di solidarietà e comprensione.
![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
![]()