|
IL BANCO DI LETTURA dal numero 32/2006 |
![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
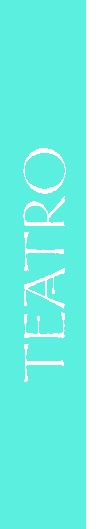 CRITICA
E CRONACA TEATRALE
CRITICA
E CRONACA TEATRALE
a cura di Paolo Quazzolo
estratto da RUBRICHE, dalla pagina 84 del n° 32/2006
 |
| Gaspare Gozzi in una incisione di Francesco Bartolozzi |
Critica e cronaca teatrale sono termini che molto spesso tendono ad essere confusi tra loro, sebbene vadano a indicare due tipi di attività non del tutto sovrapponibili e le cui finalità sono, per certi aspetti, addirittura opposte. Quella che generalmente si usa definire "critica" allo spettacolo, in realtà è una cronaca drammatica, ossia una forma giornalistica destinata a dare notizia di un evento teatrale, con grande immediatezza. Il redattore è - o dovrebbe essere - persona dotata di cultura ed esperienza teatrali, uno spettatore intellettualmente privilegiato, in grado non solo di offrire un resoconto della serata, ma soprattutto di interpretare lo spettacolo, di suggerire ai lettori delle chiavi di analisi e infine, in base ai propri canoni estetici, esprimere un giudizio di valore sulla rappresentazione.
La cronaca teatrale nasce in epoche assai lontane. Per certi aspetti si può parlare di attività critico-informativa già nell'antichità classica, con le didascalie che accompagnavano la pubblicazione dei testi teatrali o gli interventi dei filologi che davano informazioni sulla rappresentazione e sui suoi esiti. Si deve attendere però il XVII secolo, con la comparsa delle prime gazzette a stampa e l'apertura dei primi teatri pubblici a pagamento, per assistere all'avvio di una sporadica attività cronachistica. Nel Settecento, il progressivo imborghesirsi della società e il diffondersi della stampa periodica, assicurano una maggiore popolarità alla cronaca degli spettacoli: basti ricordare a questo proposito i contributi di Gasparo Gozzi pubblicati sulla "Gazzetta veneta", tra il 1760 e il 1761.
Con il diffondersi, a metà Ottocento, della stampa quotidiana d'informazione, la cronaca teatrale inizia a occupare gli spazi e le funzioni che attualmente detiene: si tratta di interventi regolari, inseriti in pagine prestabilite, destinati a dare un rendiconto delle serate teatrali. In questo periodo inizia a prendere forma anche la prima netta differenziazione tra gli interventi di carattere puramente informativo - ossia quelli dal tono brillante e destinati soprattutto al pettegolezzo - da quelli culturalmente più impegnati, volti a una precisa attività critica.
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, in ambito italiano, prese forma la cosiddetta appendice, ossia un intervento critico posto nel taglio basso della pagina e affidato per lo più a firme celebri e autorevoli. In questa vasta produzione rientrano i nomi di Luigi Capuana, Leone Fortis, Arrigo Boito, Giulio Piccini (cronista della "Nazione" con lo pseudonimo di Jarro) e, nel Novecento, Marco Praga, Domenico Oliva, Renato Simoni e Silvio D'Amico.
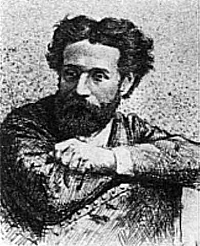 |
| Marco Praga |
Dopo aver vissuto un'epoca d'oro, ricca di vivacissimi dibattiti, oggi la cronaca drammatica sta conoscendo un periodo di recessione. Sempre più esiguo è lo spazio che ad essa viene riservato sia sui quotidiani che sui periodici. Il moltiplicarsi delle occasioni, l'abitudine ai grandi eventi, ha portato spesso a trascurare - soprattutto sulla stampa nazionale - il ruolo della recensione: molti spettacoli vengono ignorati e i pochi che salgono agli onori della cronaca sono trattati in modo frettoloso e impreciso. Ciò che al lettore interessa, è sapere se vale la pena di assistere a uno spettacolo, se una produzione ha il sapore dell'evento oppure di normale routine, se il pubblico ha applaudito o contestato gli interpreti. Tutto questo è conseguenza del diverso modo di andare oggi a teatro: le offerte sono molte, il tempo a disposizione poco, la concorrenza televisiva altissima. Il recensore quindi non deve attardarsi su considerazioni estetiche, ma fornire rapide informazioni, limitandosi spesso al ruolo di propagandista dello spettacolo.
La critica drammatica è, viceversa, una forma saggistica che appare su periodici scientifici o pubblicazioni specializzate, destinata a offrire una serie di riflessioni sui contenuti estetici, culturali e interpretativi dello spettacolo. Non comparendo quindi su un quotidiano, essa non ha l'obbligo dell'immediatezza e del racconto mondano. Qui interessano soprattutto le riflessioni di natura più strettamente critica, delle considerazioni fatte a posteriori, spesso ricorrendo ad ampie citazioni e confronti con spettacoli diversi e lontani nel tempo. Nella cronaca, la ristrettezza dei tempi e degli spazi non permette di analizzare in modo soddisfacente lo spettacolo; nel saggio critico l'autore ha a disposizione un lasso di tempo maggiore e spazi più estesi. I lettori cui si rivolge sono generalmente meno numerosi ma più specializzati e le loro attese guardano essenzialmente al dato estetico. Il saggio critico è generalmente redatto da studiosi e offre una serie di riflessioni che analizzano le scelte interpretative di uno spettacolo, ne commentano le soluzioni sceniche, ne valutano le tecniche recitative. Si tratta di contributi volti ad arricchire la storia del teatro e lo studio dello spettacolo, anche in vista di nuovi approcci metodologici.
I parametri di giudizio in base ai quali opera un critico sono vari: la cultura personale, la conoscenza della storia del teatro, gli studi compiuti, la frequentazione delle sale di spettacolo, nonché indirizzi di carattere politico (personali o della testata), che influenzano il giudizio e la lettura di uno spettacolo e che fanno del giudizio critico un'attività in gran parte soggettiva e difficilmente poggiata su basi scientifiche.
Sebbene differenti tra loro, critica e cronaca drammatica rimangono due validi mezzi per documentare un evento teatrale, utili ai posteri per ricostruire le sorti e le caratteristiche di una rappresentazione.
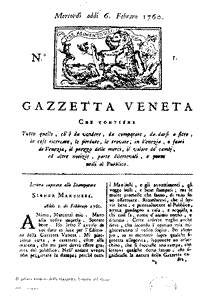 |
| La Gazzetta veneta |
Spesso ci si chiede quali possano essere le influenze che cronaca e critica drammatica hanno su uno spettacolo. Gli anni "ruggenti" delle cronache teatrali tra fine Ottocento e inizi Novecento ci riportano a un momento storico estremamente vivace. L'autorità di molti critici e lo spazio concesso alle cronache, facevano addirittura temere, agli uomini di teatro, il giudizio dei recensori. Questo perché si sapeva che un parere negativo era in grado di condizionare il pubblico il quale, di riflesso, disertava lo spettacolo, con immaginabili danni economici all'impresa. Non era quindi raro che le compagnie, già durante le prove, chiedessero pareri ai critici i quali erano talora in grado di indirizzare, più o meno felicemente, l'interpretazione di un testo. Questo era possibile perché quasi tutti i critici di allora erano attivamente impegnati nel teatro come autori o come registi, per cui il loro parere non era solamente teorico, ma anche basato su una diretta conoscenza del palcoscenico. D'altra parte a una recensione negativa o non del tutto positiva faceva spesso seguito un intervento correttivo da parte del regista o del capocomico.
Oggi l'attività cronachistica ha un riflesso pressoché inesistente sullo spettacolo. La minore importanza attribuita dalla stampa alle recensioni, il basso interesse che i lettori hanno verso questo tipo di articoli, ne hanno fatto un'attività addirittura a rischio di estinzione. Un critico oggi raramente viene interpellato da una compagnia e un suo giudizio negativo può, al più, far irritare un attore, che si guarderà bene dal seguirne i consigli. Tale atteggiamento è dovuto almeno a due fattori: da un lato il sistema dei finanziamenti statali e degli abbonamenti ha reso secondario, per molte compagnie, il numero di presenze a teatro: una critica negativa, ammesso che possa influire sul giudizio dello spettatore, non riesce a pregiudicarne l'affluenza. Dall'altro sono sempre meno i critici dotati di sicure capacità analitiche e di vera autorevolezza. Il fatto stesso che quasi tutti siano solo collaboratori e non giornalisti assunti della testata per cui scrivono, spiega la precarietà di questo mestiere e l'improvvisazione che talora lo accompagna.
![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
![]()