![]()
IL BANCO DI LETTURA
estratto dal 25/2002
|
|
IL BANCO DI LETTURA estratto dal 25/2002 |
![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA
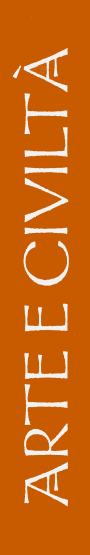 da
RUBRICHE - a cura di Roberto Curci
da
RUBRICHE - a cura di Roberto Curci
LO SPAZIO C'É, MA É POCO O TROPPO?
C’era una volta il Museo Pecci di Prato, c’era
una volta il Castello di Rivoli (Torino). Ci sono ancora, beninteso. E marciano
bene, così come han fatto per vent’anni. Ma, per vent’anni,
i cultori d’arte contemporanea - pochini, a onor del vero - hanno piagnucolato:
povera Italia, due soli centri (in tutto lo Stivale) davvero attenti alla creatività
delle ultime generazioni! Che provincialismo, che oscurantismo! Quale inconfutabile
sintomo del “passatismo” generalizzato delle istituzioni!
Poi, di botto, come spesso succede in molti ambiti, si passa dal troppo vuoto
al troppo pieno. A Rovereto va a sorgere a fine anno il nuovo Mart, 14 mila
metri quadrati comprensivi di museo, auditorium, archivi, biblioteca e servizi
(oggi ineludibili: bookshop, cafeteria, ecc.), e - su tutto - la firma rutilante
di Mario Botta. A Roma è in gestazione il faraonico Centro arti contemporanee,
da 26 mila metri quadrati, con una firma oggi ancor più intrigante, quella
dell’anglo-irachena Zaha Hadid. E centri destinati all’arte d’oggi
sono in allestimento (o in incubazione) a Brescia, Messina, Palermo, Milano
(due addirittura: il Museo del Presente e il Museo del Novecento). Forse troppa
grazia.
 Queste notizie (comunque confortanti) si prestano a una serie di riflessioni.
Non è mai ben chiaro, ad esempio, quale sia - almeno fino alla riprova
dei fatti, quando cioè è troppo tardi per rimediare - il rapporto
tra lo spazio “disponibile” di una struttura e il rispettivo, ipotizzabile
bacino di utenza: vale a dire tra la sua polivalente capienza e il numero di
coloro che, in concreto, ne fruiranno. Sicché c’è sempre
il rischio - spesso poi tradotto in amara realtà - che un centro d’arte
pensato con dovizia di idee, quattrini e cubatura risulti alla fin fine sovradimensionato
e popolato da rari estimatori o da scolaresche coatte e ciondolanti. Mentre,
al contrario, si dà il caso di folle scalpitanti costrette a stiparsi
in spazi angusti, con ben scarso appagamento estetico.
Queste notizie (comunque confortanti) si prestano a una serie di riflessioni.
Non è mai ben chiaro, ad esempio, quale sia - almeno fino alla riprova
dei fatti, quando cioè è troppo tardi per rimediare - il rapporto
tra lo spazio “disponibile” di una struttura e il rispettivo, ipotizzabile
bacino di utenza: vale a dire tra la sua polivalente capienza e il numero di
coloro che, in concreto, ne fruiranno. Sicché c’è sempre
il rischio - spesso poi tradotto in amara realtà - che un centro d’arte
pensato con dovizia di idee, quattrini e cubatura risulti alla fin fine sovradimensionato
e popolato da rari estimatori o da scolaresche coatte e ciondolanti. Mentre,
al contrario, si dà il caso di folle scalpitanti costrette a stiparsi
in spazi angusti, con ben scarso appagamento estetico.
Un esempio: nella trevigiana Casa dei Carraresi, per quella mostra su “L’Impressionismo
e l’età di Van Gogh” (dal 9 novembre al 30 marzo) per la
quale già da mesi rimbomba il tam-tam mediatico dell’ottimo Marco
Goldin, si può star certissimi di godere ben poco della creatività
dei Maestri di turno, impegnati come sempre si è, in quello spazio affatto
inadeguato, in un’attività fisica (accalcamenti, aggiramenti, spintonamenti,
fughe in avanti) forse salutare ma un tantino stressante. E tuttavia, già
a metà agosto, centomila candidati erano in adorante lista d’attesa,
pronti anche a subire non improbabili attacchi di panico nella ressa proverbiale
e scontata.
Identico fenomeno si ripete giornalmente, da sempre, nel veneziano Palazzo Venier
dei Leoni, sede della collezione Peggy Guggenheim, vi si tengano o meno provvisorie
mostre tematiche. Ma qui il caso è ben diverso: per la storicità
dell’insostituibile complesso, per l’urbanità della netta
maggioranza di visitatori stranieri, mai strepitanti, e per le vie di fuga rappresentate
dal giardino interno, dall’imbarcadero sul Canal Grande e dall’ottima
“cafeteria”. Possibile invece che a Treviso - coi poderosi mezzi
di cui dispongono - Cassamarca e Linea d’ombra non pensino a un sito alternativo
che consenta di sfuggire alle ammucchiate pazzesche di Casa dei Carraresi? Vi
sono poi dei casi felici e fortunati, di equilibrio raggiunto non si sa se per
grazia di Dio o per oculatezza dei responsabili terreni: il Palazzo dei Diamanti
di Ferrara, ad esempio, struttura non certo immensa, ospita sempre con un erto
garbo e senza traumi i visitatori delle sue indovinatissime mostre. Anche qui
risuona accortamente il tam-tam promozionale, ma il potere d’attrazione
di Dosso Dossi, di Max Klinger, dei paesaggisti nordici, di Alfred Sisley di
John Singer Sargent - “Sargent e l’Italia” è aperta
dal 22 settembre al 6 gennaio, e ha il grande merito di illuminare uno squisito
ritrattista paradossalmente quasi ignoto nel Paese in cui pur nacque - non è
evidentemente il riedesimo degli Impressionisti cari a Goldin. Pubblico dunque
più raffinato, preparato, motivato. Pubblico che abbina la capatina a
Palazzo dei Diamanti ila visita (o alla rivisitazione) di una “città
del silenzio” ancora tra le più vivibili e gentili.
 Altrove
il problema è opposto: grandi mostre, anzi “eventi”, ospitati
in spazi sontuosi e perfino ridondanti, in cui - ospiti quasi solitari - si
rischia di essere scrutati da capo a piedi da occhiuti custodi praticamente
disoccupati, vista la sconsolante affluenza. Va detto: gli “eventi”,
se non sono propriamente tali, spesso si tramutano in rovinosi flop. Vai a sapere,
poi, che cosa non abbia funzionato. L’idea stessa, probabilmente. Il personaggio,
il movimento, il momento storico cui la rassegna taldeitali è stata dedicata.
Al di là, badate bene, della sua effettiva valenza culturale, al di là
dunque della sua correttezza e della sua scientificità.
Altrove
il problema è opposto: grandi mostre, anzi “eventi”, ospitati
in spazi sontuosi e perfino ridondanti, in cui - ospiti quasi solitari - si
rischia di essere scrutati da capo a piedi da occhiuti custodi praticamente
disoccupati, vista la sconsolante affluenza. Va detto: gli “eventi”,
se non sono propriamente tali, spesso si tramutano in rovinosi flop. Vai a sapere,
poi, che cosa non abbia funzionato. L’idea stessa, probabilmente. Il personaggio,
il movimento, il momento storico cui la rassegna taldeitali è stata dedicata.
Al di là, badate bene, della sua effettiva valenza culturale, al di là
dunque della sua correttezza e della sua scientificità.
A noi, ad esempio, la scorsa primavera è sembrata corretta e scientificamente
dignitosa la mostra milanese sul “Neoclassicismo in Italia da Tiepolo
a Canova” (dove però i due grandi nomi erano essenzialmente specchietti
per allodole), allestita a Palazzo Reale. Eppure, era una mostra gelida, poco
affabile e apparentemente ben poco visitata (non disponiamo, comunque, dei dati
definitivi di affluenza): una mostra che forse risentiva del gelo catacombale
connaturato al movimento estetico di cui trattava.
A questo punto, il senso del nostro sproloquio dovrebbe risultar semplice e
perfin banale: indovinare una mostra è un temo al lotto, render appetibile
uno spazio votato all’arte è una quaterna, conciliare poi il buon
contenuto di una rassegna con il buon appeal del contenitore è una cinquina
secca.
Meglio - occorre dirlo - vanno le cose nei centri minori e minimi, dove comunque
i pericoli di barbariche invasioni di visitatori assatanati sono decisamente
limitati. Occorre dunque uscire dalle autostrade viarie e culturali, imboccare
vie secondarie, semplici “provinciali” magari sconnesse: si può,
ad esempio, raggiungere con grande godimento dell’anima e del corpo (massi,
ci sta anche un assaggio di vermiglio Sagrantino!) la dolcissima Montefalco
umbra, e capire perché mai Benozzo Gozzoli, nonostante sia stato indubitabilmente
un nostalgico del Gotico in pieno e trionfante Rinascimento, valga ben più
di quanto la pur smagliante Storia dei Magi nel fiorentino Palazzo Medici Riccardi
potesse far subodorare. O spingersi - difficile in questo caso evitare le autostrade…
- a Varese e incantarsi, al castello di Masnago e a Villa Panza (“Il ritratto
in Lombardia da Moroni a Ceruti. 1550-1750”), dinanzi a una sequenza indimenticabile
di facce toste e vere, tra cui sembra di riconoscere (toh…) amici e nemici,
e magari anche qualche parente.
Sì, certo: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino. Sono e restano le
capitali. Ma il futuro dell’arte pare proprio passare per la provincia.
Rovereto, Prato, Rivoli, dicevamo all’inizio, a proposito dell’arte
d’oggi. Aggiungiamoci, per il passato prossimo e remoto, Treviso - con
tutte le riserve di cui sopra -, Ferrara, Verona col suo Palazzo Forti (un po’
in decadenza, azzardiamo), e poi Cremona, e ancora Trento (ben mirata e documentata
la rassegna sul “Gotico nelle Alpi”, al Castello del Buonconsiglio,
fino al 20 ottobre).
 E poi, e poi…
ma Brescia, perbacco!, che è diventata una città-pilota nell’allestimento
di rassegne intelligenti e “diverse”. L’altr’anno “Impressionismi
in Europa. Non solo Francia”, quest’anno “Dubuffet e l’arte
dei graffiti” (Palazzo Martinengo, fino al 6 ottobre) per i cultori dell’arte
moderna e, per i fans di quella antica, “Vincenzo Foppa. Un protagonista
del Rinascimento”: vale a dire un’immersione nella straordinaria
libertà mentale e verbale del creatore dell’Art Brut (e precursore
del graffitismo di Haring e Basquiat), e la scoperta stordente - non diciamo
la riscoperta, alzi la mano chi sapeva qualcosina di Foppa, salvo (forse) il
nome - di un grande artista rinascimentale, attivo fra Lombardia e Liguria a
cavallo tra ‘400 e ‘500, noto famoso al suo tempo (fu conteso da
grandi committenti: gli Sforza, i Portinari e il futuro Papa Giulio II) ma oscurato
nei secoli a seguire, nel male si fusero in maniera personalissima le lezioni
di Donatello, del Mantegna e dei maestri fiamminghi. Questo sì, un “evento”:
ben pensato, ben allestito, ben pubblicizzato, con affissioni murali in tutta
Italia. Un segno di perdurante vitalità culturale della città
lombarda, dopo le mostre dedicate a Romanino, Moretto, Savoldo e Ceruti.
E poi, e poi…
ma Brescia, perbacco!, che è diventata una città-pilota nell’allestimento
di rassegne intelligenti e “diverse”. L’altr’anno “Impressionismi
in Europa. Non solo Francia”, quest’anno “Dubuffet e l’arte
dei graffiti” (Palazzo Martinengo, fino al 6 ottobre) per i cultori dell’arte
moderna e, per i fans di quella antica, “Vincenzo Foppa. Un protagonista
del Rinascimento”: vale a dire un’immersione nella straordinaria
libertà mentale e verbale del creatore dell’Art Brut (e precursore
del graffitismo di Haring e Basquiat), e la scoperta stordente - non diciamo
la riscoperta, alzi la mano chi sapeva qualcosina di Foppa, salvo (forse) il
nome - di un grande artista rinascimentale, attivo fra Lombardia e Liguria a
cavallo tra ‘400 e ‘500, noto famoso al suo tempo (fu conteso da
grandi committenti: gli Sforza, i Portinari e il futuro Papa Giulio II) ma oscurato
nei secoli a seguire, nel male si fusero in maniera personalissima le lezioni
di Donatello, del Mantegna e dei maestri fiamminghi. Questo sì, un “evento”:
ben pensato, ben allestito, ben pubblicizzato, con affissioni murali in tutta
Italia. Un segno di perdurante vitalità culturale della città
lombarda, dopo le mostre dedicate a Romanino, Moretto, Savoldo e Ceruti.
Concludiamo con qualche annotazione sparsa, da bloc-notes. Appunti presi durante
una stagione espositiva comunque non memorabile, e che ha anche avuto qualche
caduta di tensione e di gusto su cui è forse meglio sorvolare. E’
stata una stagione discreta per l’arte del Novecento, con le mostre su
Jackson Pollock a Venezia e sulle opere del Whitney Museum (“New York
Renaissance”) a Milano, ma soprattutto - a parer nostro - con le rassegne
“complementari” dedicate a George Segal (Museo Arte Contemporanea
di Roma) e a Duane Hanson (PAC di Milano): due grandi retrospettive di artisti
“pop”, a pochi anni dalla loro scomparsa, in cui attraverso un’analoga
ideazione di “sculture viventi” si fruga con impietosa ironia nell’altra
faccia del “sogno americano” (o occidentale), nell’orrore
quotidiano di esistenze vuote, rassegnate, solitarie. Le gessose figure di Segal
e i coloriti, iperrealistici calchi di Hanson sembrano davvero i relitti umani
di una novella Pompei, i patetici resti di un’eruzione catastrofica, che
ha spazzato sentimenti e illusioni, e li ha ricoperti con la cenere del più
irrimediabile disincanto.
E, ancora a proposito di arte moderna, due itinerari possibili per rendere omaggio
a una figura di cui si avvertirà assai la mancanza: Niki de Saint-Phalle,
deceduta in maggio a San Diego. Il primo porta a Nizza, dove al Museo d’arte
moderna (fino al 28 ottobre) è visitabile la mostra delle oltre trecento
opere lasciate in donazione dalla geniale scultrice parigina; il secondo conduce
alla minuscola Garavicchio, presso Capalbio, in Toscana, dove Niki, in poco
meno di vent’anni, ha dato vita al Giardino dei Tarocchi, un parco popolato
di enormi sculture, a metà strada - com’è stato scritto
- tra Gaudì e un Luna Park.
Anche questo un dono, fatto dall’artista agli italiani, del quale però
non si sa se gli italiani sapranno esser degni. Un dono che, per ignoranza e
noncuranza, rischia di finire nella spazzatura, come certi regali indesiderati,
fatti da vecchi zii ai quali si dice “grazie” a denti stretti, senza
alcuna riconoscenza. Sarebbe un gran peccato. Sarebbe, anzi, un peccato mortale.
PS. Vabbè, direte voi, queste pero son quisquilie. Ci si dica qualcosina,
piuttosto, delle grandi firme dell’autunno: Rembrandt a Roma, alle Scuderie
del Quirinale (fino al 6 gennaio); i Gonzaga a Mantova (e dove se no?), a Palazzo
Te e a Palazzo Ducale (fino all’8 dicembre); Renoir a Milano, alla Fondazione
Mazzotta (fino al 17 novembre); Masaccio a San Giovanni Valdarno, alla Casa
Masaccio (fino al 21 dicembre); e, perché no?, i Faraoni a Palazzo Grassi
(fino al 25 maggio 2002: no, non è un refuso...).
Un po’ di pazienza, rispondiamo. Dateci il tempo di delibare tutto questo
(presunto) ben-di-Dio. Possibilmente ben lungi dal pigia-pigia dei vernissage.
O no?